
Antonio Giuseppe Malafarina
Questa volta Antonio Giuseppe Malafarina, giornalista, scrittore, poeta, persona con disabilità motoria, una delle principali “firme” del blog InVisibili del «Corriere della Sera.it» e anche di «Superando.it», non è l’autore di un articolo, ma il protagonista dell’intervista curata da Zoe Rondini, cui di seguito diamo spazio. Ed è «un’ intervista appassionata – come scrive la stessa Zoe Rondini – che porta con sé tante riflessioni sui diritti, l’accessibilità, il lavoro, il mondo universitario, il “Dopo di Noi”, la famiglia, l’amore, il diritto alla salute e molto altro».
Leggendo la tua storia, Antonio, emerge subito un punto di svolta, un momento a partire dal quale tante cose sono cambiate e hai dovuto imparare a convivere con una disabilità. Come hai vissuto questo passaggio? Quanto tempo ci è voluto per prendere confidenza con la tua nuova vita?
«Il punto di svolta è stato il 13 settembre del 1988, ma non è stato un punto di svolta come si potrebbe immaginare. Era l’ultimo giorno di ferie in Calabria, l’esame della patente di guida superato tranquillamente e un ultimo tuffo con gli amici. In verità venuto maluccio ed ecco che immediatamente mi ritrovo tetraplegico e senza respirare. Per fortuna c’è un medico che mi aiuta, il classico colpo di fortuna da film. Mi portano vigile in ospedale e non sanno cosa fare. Dicono che non arrivo a sera. Non bravi a fare previsioni!
I miei fanno di tutto per portarmi a Milano, dove abitiamo, mi risveglio dai sedativi nel cuore della notte di quel giorno, nell’allora centro fra i più avanzati per il trattamento acuto delle lesioni spinali in Lombardia, l’Ospedale di Legnano. I miei hanno fatto grandissimi sacrifici per salvarmi la vita. Situazione critica per una quindicina di giorni e poi si stabilizza. Paralizzato in un letto di ospedale, senza per nulla chiaro il mio futuro, prendo atto della condizione e rivendico il mio ruolo sociale. La mia vita continua, qualcosa farò.
Dunque, non c’è stato, nella mia storia, il dramma dell’impatto con la disabilità. Ne ho preso coscienza e sono andato avanti. L’ho subito considerato come un fatto acquisito ormai ineludibile. Per questo, dal punto di vista caratteriale, non posso parlare di una cesura fra prima e dopo il tuffo. Anzi, c’è una continuità: io ero lo stesso, benché in un’altra condizione.
Dopo quindici mesi di rianimazione, di cui tre in Francia per l’applicazione di un pacemaker diaframmatico per respirare da solo, sono tornato a casa. All’epoca ero una delle poche persone non autosufficienti e con compromissione del respiro a casa in Italia. Per questo c’è stato bisogno di due genitori straordinari, di grandi amici, di disponibilità sanitaria e di forza di carattere. Non solo mia. Vogliamo metterci anche un po’, un bel po’, di fede in Dio? Aggiungiamola».
Appassionato di meccanica, a seguito dell’incidente hai esplorato nuove e diverse opportunità, senza precluderti nulla, come racconti tu. Poi l’approdo alla scrittura e alla comunicazione, delle quali riesci a sfruttare tutto il potenziale al servizio di una maggiore conoscenza e consapevolezza sul mondo della disabilità. In che modo, a tuo avviso, è cambiata negli anni la percezione della disabilità e la narrazione di questa?
I giovani danno per scontato che il mondo della disabilità sia fatto come lo trovano ora, cioè che si debba lottare per il rispetto dei diritti. Bisogna ricordare che trent’anni fa e passa, però, non c’erano nemmeno i diritti. Non si trattava di chiederne il rispetto, si trattava proprio di chiedere che venissero sanciti. Il divario da allora è enorme.
Le cose continuano a non funzionare bene, ma funzionano meno male di prima. Faccio un esempio. Oggi ti discriminano a scuola, una volta praticamente no. Non tanto perché la gente era migliore, bensì perché a scuola nemmeno ci arrivavi, tante erano le difficoltà da superare. Oggi abbiamo lo sport paralimpico, con campioni che il mondo ci invidia. Fanno persino pubblicità a prodotti che nulla hanno a che fare con la disabilità. Fino ad alcuni anni fa certi marchi disdegnavano di essere accostati alla disabilità.
Se le persone con disabilità oggi arrivano sui media, vuol dire che qualcosa è cambiato. Vuol dire che, almeno ufficialmente, c’è maggiore livellamento tra persone con disabilità e non. Poi resta il fatto che la mentalità non si cambia in un giorno, quindi resta ancora molta discriminazione. I media ne parlano, alcune volte ci ricamano. C’è un problema di linguaggio, nei media. Bene, cioè, che si parli di disabilità e non solo in chiave negativa, ma bisogna trovare il registro giusto. Le persone con disabilità devono essere trattate obiettivamente. Non siamo solo “eroi o sventurati” perché siamo disabili. I media devono imparare a usare i toni e il linguaggio giusto. Perché la disabilità, come la politica, lo sport, l’economia e ogni argomento specifico, ha il suo linguaggio».
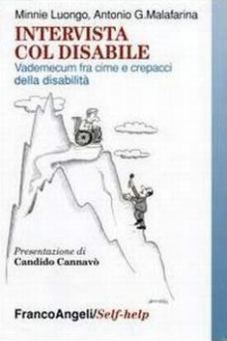
La copertina di “Intervista col disabile. Vademecum fra cime e crepacci della disabilità”, libro scritto da Antonio Giuseppe Malafarina con la giornalista Minnie Luongo
Qual è il tuo rapporto con la scrittura? Da dove nasce questa esigenza e vocazione? Come vi siete incontrati?
«Per me scrivere è confrontarsi con se stessi ad alta voce. Ogni volta che butti giù una parola e la concateni con le altre per esprimere il tuo pensiero, compi un processo che ti mette in relazione profonda con il tuo essere. In questo processo hai l’opportunità di mettere a confronto i tuoi pensieri. E i tuoi pensieri con quelli degli altri. La mia esigenza espressiva, pertanto, nasce dal desiderio di rapportarmi con me stesso e di farlo in maniera tanto tangibile da averne una traccia scritta. Che, poi, quando scrivi e hai le cose davanti ci ragioni meglio.
Non so bene da dove nasca questa esigenza, ma ti posso dire che quando ero in Francia, nel 1989, mi diedero la possibilità di scrivere con un computer. Io, paralizzato, potevo usare un computer per scrivere: non mi sembrava vero. Chiesi di poter scrivere quello che volevo e mi lasciarono fare. Un’ora a settimana, mi pare, nel laboratorio di ergoterapia.
In Italia quasi non c’erano i computer e lì, in un ospedale, io potevo usarne uno per scrivere. In tre mesi ho scritto una lettera e un paio di racconti. Con un sistema primitivo, per cui sul monitor scorrevano le lettere dell’alfabeto e dovevo pigiare un pulsante con la testa quando desideravo battere la lettera che mi interessava. Sembra, ed è, un processo impegnativo. Ma quando sei motivato, la fatica si mette da parte».
Ho letto che hai una brillante carriera, ma hai trovato degli ostacoli nel mondo universitario per via della tua disabilità. A tuo avviso, cosa è mancato e cosa si potrebbe migliorare nell’università per andare incontro alle esigenze degli studenti con disabilità?
«All’epoca – parliamo della metà degli Anni Novanta – alla Statale di Milano c’era già un servizio di volontariato che aiutava le persone con disabilità a muoversi in università, a prendere appunti e a sbrigare un mucchio di pratiche. Ragazzi bravissimi.
Non ce l’ho fatta perché non avevo gli strumenti. Studiare bene voleva dire consultare molti libri, più di quelli richiesti, e non c’erano libri digitali. Dovevo arrangiarmi con uno strumento meccanico che girava malamente le pagine e non gradiva tutti i libri. Oggi la tecnologia aiuta molto le persone con disabilità. Di più può essere fatto nell’àmbito del rapporto personale fra università e allievo. Bisogna rendere l’apparato dell’istruzione sempre più flessibile, capace di rispondere alle esigenze del singolo. Se c’è bisogno di interrogare fuori orario lo si faccia. Se una prova scritta richiede che sia adattata in un certo modo lo sia. Inoltre, temo ci siano aule dove le persone con disabilità non possono entrare per questioni di barriere e l’abbattimento si scontra con il valore artistico dell’aula, che non può essere toccata poiché bene di interesse culturale.
Ecco, facciamo in modo che le persone con disabilità non debbano mai rinunciare a frequentare luoghi prestigiosi per via delle barriere. Rispetto alle barriere, ci sono luoghi che probabilmente non saranno mai accessibili, ma se quel luogo non è accessibile, se ne trovi un altro di pari dignità da mettere a disposizione accessibilmente. Se non esiste, si conferisca prestigio a un ambiente accessibile».
Attraverso la tua attività e le tue parole promuovi l’importanza del vivere dignitosamente. A tal proposito, mi viene in mente l’appello di molti genitori al fine di realizzare un programma concreto per il “Dopo di Noi” e migliorarne la relativa Legge [Legge 112/16, N.d.R.]. La paura più ricorrente è che i figli, raggiunta l’età adulta, finiscano in istituti mal gestiti. Perché, in molti casi, è così complicato avere una prospettiva di vita soddisfacente? Cosa si potrebbe cambiare per migliorare la qualità della vita di molte famiglie nel “Durante Noi” e nel “Dopo di Noi”?
«Sulla carta la situazione è semplice: guardi alle esigenze di una persona con disabilità, vedi quello che fa la famiglia e, affetti a parte, crei un apparato che sostituisca la famiglia stessa. Costoso, certo, ma questa è la soluzione. Pare giusto che le famiglie, pur con tutto l’amore che ci mettono, debbano fare qualcosa che spetterebbe allo Stato fare? Perché le famiglie sono obbligate a prendersi cura della persona? Lo Stato se ne approfitta.
Detto questo, non mi piacciono le politiche sul “Dopo di Noi” che sono state adottate perché, quando i miei non ci saranno più, ma anche ora che sono anziani, io avrò enormi difficoltà. Non ho la certezza che potrò continuare a vivere nella mia casa, adeguatamente assistito, pur provvedendo io stesso alle spese per la casa, l’alimentazione, l’abbigliamento e via dicendo.
Abbiamo risolto la questione del “Dopo di Noi”? No. Abbiamo creato un sistema che favorisce certe pratiche, come la coabitazione, ma non è questa la risposta giusta alla domanda. Mi duole che ci siano tante famiglie che fanno una fatica terribile a mettere da parte qualche spicciolo per quando i loro figli rimarranno soli e questi spiccioli siano considerati ricchezza.
Se metti qualche cosa da parte lo Stato ti considera ricco, non vede che quel patrimonio serve a rispondere all’esigenza di sopravvivenza cui lo Stato stesso non risponderà quando la persona resterà da sola. Così ti beffa due volte: una perché al momento del bisogno non ti dà quello che ti serve e due perché mentre ci sono i tuoi considera “ricchezza” il tuo patrimonio, e te lo tassa o ti toglie servizi. Le politiche sul “Dopo di Noi”, ad esempio, non potevano detassare i patrimoni delle famiglie di persone con disabilità gravissima? Non si poteva fare in modo che il patrimonio non venisse considerato ricchezza, ma cumulo per la sussistenza? Mi sembra elementare. Non è stato fatto».
Prima che diventassi giornalista, nel 2007 è uscito il tuo libo Intervista col disabile. Vademecum fra cime e crepacci della disabilità, scritto con la giornalista Minnie Luongo e ti sei dedicato alla poesia con il testo intitolato semplicemente Poesia. Qual è la forma di scrittura che maggiormente prediligi?
«Il mio primo amore è la prosa. Sono approdato alla poesia per caso: un concorso in una parrocchia vicino casa, non ricordo neppure perché, mi aveva interessato.
Passo molto tempo a scrivere in prosa come giornalista e scrivo versi di quando in quando. Non mi ritengo un poeta e di me dico che non scrivo poesie, faccio solo “versacci”. Trovo che fra scrittura in versi e scrittura in stile giornalistico vi sia molto in comune: entrambi i metodi richiedono sintesi e compiutezza di parole. Quindi salto dalla prosa alla poesia con discreta disinvoltura».

La copertina di “Poesia”, antologia di scritti in versi pubblicata da Antonio Giuseppe Malafarina
Quali ritieni siano le qualità del tuo carattere, le competenze e le persone che ti hanno maggiormente aiutato nel percorso di crescita personale e professionale? E vuoi dare un consiglio a chi ti vede come un modello da seguire?
«So di essere una persona coerente e questo, alle volte, diventa un difetto. Non sono zelante, però mi piace che le persone siano rispondenti nel loro agire a quello che dicono. Quando non lo fanno, mi indignano o mi deludono. Nell’essere coerenti bisogna tenere conto che si possa anche essere incoerenti qualche volta, perché la coerenza concepisce di poter cambiare punto di vista. Ad ogni modo la coerenza diventa un’arma a doppio taglio perché le persone coerenti qualche volta non vengono ben viste.
Detto questo, sono stato aiutato da moltissimi e sono a tutti riconoscente. Cerco di aiutare perché credo nella potenza del fare rete. Credo nella comunità. Non penso di essere un modello da seguire, anche se ti ringrazio per averlo pensato. Essere un modello vuol dire assumersi delle responsabilità. Io me ne assumo comunque. Perché per stare al mondo devi assumerti delle responsabilità. Da adolescente mi sono assunto quella di essere me stesso. Facile a dirsi, perché se uno ha dentro un sé malvagio, non è bello che sia semplicemente se stesso. Quindi mi sono impegnato e mi impegno per essere un me stesso migliore. Cerco di trarre il massimo dei buoni valori della società per acquisirli e a mia volta diffonderli. Pertanto dico alle persone di non cercare di essere altri da sé, bensì di migliorare il proprio sé affinché sia il più utile possibile al benessere di tutti».
Hai dichiarato che credi nella collettività, nella capacità delle persone, nella bellezza e in Dio. Hai scelto cose non da poco! Come si declinano questi elementi nella tua vita?
«Si declinano con il mio essere. Cerco una bellezza interiore che si nutre di quella intorno e, certamente, non è solo estetica. Non mi nutro della mia bellezza, bensì di quella che trovo negli altri e che non si ferma all’apparenza.
La collettività ha il suo aspetto affascinante nell’essere sistema, dove si opera solidalmente per andare avanti tutti insieme, almeno nell’ideale. Le persone mi conquistano quando fanno qualcosa di bello, e basta poco, alle volte basta un’occhiata.
Dio è un’entità che mi ha catturato molti anni fa e che vivo con senso critico, benché in una certa parte insondabile, altrimenti non sarebbe fede. Riassumendo, perciò, credo nell’universo, che è capace di meravigliarmi. Credo nella meraviglia».
Oggi si fa più attenzione al cosiddetto “politically correct”. Quali sono i termini che ritieni più opportuni legati al giornalismo sociale? A tuo avviso qual è il rapporto tra la terminologia e la realtà quotidiana?
«Il linguaggio sbagliato è figlio di ignoranza e l’ignoranza indica un malessere. Nell’ignoranza si può essere vittime degli altri, ma dall’ignoranza si può uscire.
Dico che il linguaggio è figlio dell’ignoranza perché il linguaggio sbagliato proviene o dalla non conoscenza dei codici o dalla volontà di sopprimere qualcuno. I totalitarismi usano linguaggi sbagliati, cioè giusti ai loro occhi ma inappropriati verso la dignità umana, e qui sta l’ignoranza dell’oppressore, nell’ignorare con la sua sopraffazione i diritti altrui, ecco perché ritengo ignorante chi deliberatamente usa il linguaggio sbagliato.
L’ignoranza va combattuta, superata, che sia veniale o intenzionale. Secondo me oggi assistiamo a un imbruttimento della terminologia. Usiamo un limitato numero di parole, per colorire i discorsi ricorriamo alle parolacce e appena possiamo demandiamo a concetti precompilati, come i disegnini. L’impoverimento sembra figlio di un generale depauperamento di pensiero, senz’altro di una pigrizia che non giova. Il rischio è che l’impoverimento del linguaggio impoverisca il pensiero, perché se eviti lo sforzo di esprimerti in una certa maniera, finisce che poi ti esprimi per luoghi comuni.
Quanto ai termini del sociale, vorrei parlare di termini della disabilità, che più mi competono. Ma il discorso è lungo perché il lessico della disabilità è fatto di poche ma decisive regole che vanno esaurite in apposita sede. Dico solo che dobbiamo capire che la disabilità sta nel rapporto fra la persona con la sua condizione di salute e l’ambiente circostante e che questo non lo dico io, ma l’Organizzazione Mondiale della Sanità attraverso l’ICF, ovvero la Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute».

Un’altra immagine di Antonio Giuseppe Malafarina
La redazione degli InVisibili del «Corriere della Sera.it», dall’esterno appare un progetto davvero vincente, in grado di integrare professionisti con disabilità e non, restituendo alla società spunti di riflessione arricchiti dai diversi vissuti di ciascun giornalista. Come siete arrivati alla realizzazione di questo progetto e c’è qualcosa nel vostro team che si potrebbe replicare in altre realtà?
«Tutto è nato molti anni fa, grazie all’intuizione di Alessandro Cannavò e Simone Fanti sostenuti dal “Corriere della Sera” per cui lavoravano. Senza l’apporto e la fiducia del giornale, il blog non sarebbe esistito.
Subito arrivarono Franco Bomprezzi, il più grande giornalista sulla disabilità del nostro Paese [direttore responsabile di “Superando.it” fino alla sua scomparsa nel 2014, N.d.R.], e Claudio Arrigoni, straordinaria firma dello sport non solo paralimpico. Si voleva dare spazio alle questioni della disabilità in maniera autorevole, ma non autoreferenziale. È nata una redazione dedicata alla disabilità decisa ad affrontare il tema in maniera professionale, senza fronzoli e pietismi.
Noi pensiamo che il nostro team debba essere assolutamente replicato, soprattutto nel campo della disabilità. Ci vogliono preparazione sui temi della disabilità, attenzione al linguaggio, rispetto per le persone e capacità di fare squadra».
In un tuo recente articolo ti sei occupato della sottotitolazione dei video pornografici su una nota piattaforma web, a seguito del ricorso di un utente negli Stati Uniti che, a causa della propria sordità, lamentava di non poter fruire al 100% dei contenuti offerti. Ho trovato interessante la tua riflessione sull’accessibilità del sito anche per le persone con disabilità e da qui deriva la mia curiosità di conoscere la tua opinione in merito alla sessualità delle stesse e alla figura dell’“assistente sessuale”. Sappiamo che quest’ultima non ha ancora ottenuto nel nostro Paese riconoscimento professionale. Credi che potrebbe essere un supporto utile per i diretti interessati e per loro famiglie?
«Partiamo da una considerazione: le persone con disabilità sono sessuate. Hanno, quindi, una loro naturale sessualità, benché nell’ideale delle persone ne abbiano al pari degli angeli. Se non si considera un aspetto di una persona, ci si priva della possibilità di percepirla pienamente.
È noto che la mentalità da superare è quella che considera la persona in carrozzina la sua disabilità, cioè che di una persona con disabilità si veda solo la disabilità. In quest’ottica bisogna oltrepassare la mentalità della non partecipazione affettiva e sessuale della persona disabile alla società.
Bisogna comprendere che la persona con disabilità è e resta una persona. In quanto persona, pertanto, non solo ha pari dignità, ma ha medesime caratteristiche umane, proprio perché umana. Tali caratteristiche possono essere condizionate dalla disabilità, ma ne sono preesistenti. Potremmo dire esistenti a priori.
Venendo al dunque, è ingiusto negare la sessualità delle persone con disabilità, proprio perché insita nell’essere umano. Bisogna naturalmente considerare che ogni persona è a sé e quindi ognuno vive e manifesta la propria sessualità a modo suo. E ci sono disabilità che compromettono il pieno esercizio della sessualità. Ma è il concetto di sessualità che dev’essere riconsiderato, abbracciando quello dell’affettività. In soldoni, se ognuno ha una sua sessualità, bisogna fare in modo che questa venga considerata e che non diventi un ulteriore ostacolo per la persona.
Non esiste un diritto all’amore, ma esiste un diritto alla salute e un buon rapporto con il proprio corpo dal punto di vista sessuale ricade nel diritto alla salute. Ciò detto, la società deve imparare che anche le persone con disabilità hanno una sessualità e un’affettività. Tieni presente che un buon rapporto di questo tipo si gioca attorno a quella che io chiamo complicità, una caratteristica che non può non mancare anche fra persone non disabili. Creata complicità fra persone, la sessualità e l’affettività si manifestano anche solo attraverso lo sfioramento di due dita.
Sull’“assistente sessuale” dico che innanzitutto bisogna formare la società affinché si creino i presupposti per non negare a priori relazioni con persone disabili. Quindi aggiungo che è necessario che la Sanità si occupi anche della sfera sessuale, come per altro ha iniziato a fare da alcuni anni. L’assistente sessuale può fornire risposta in alcuni casi, purché si tratti di un professionista con competenze multidisciplinari in grado di aiutare la persona a considerare la propria sessualità nella sua interezza. Interezza che si compone di fisico e psiche. Di pulsioni ed emozioni».


