
Scrive l’evangelista Matteo: «Quando si fa sera, voi dite: bel tempo perché il tempo rosseggia; e al mattino: oggi burrasca perché il cielo è rosso cupo. Sapete dunque interpretare l’aspetto del cielo e non sapete distinguere i segni dei tempi?». «Voi, “Ipocriti”! – incalza Luca -, sapete giudicare l’aspetto della terra e del cielo, come mai questo tempo non sapete giudicarlo? E perché non valutate da voi stessi ciò che è giusto?».
Perché non ci rendiamo conto del pericoloso e indiscutibilmente trasversale propagarsi di una nuova ideologia, che sta calpestando senza concrete e fattive mozioni contrarie l’articolo 32 della Costituzione [«La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana», N.d.R.]? Perché non siamo capaci – neanche solo per un giorno – di mettere da parte i nostri interessi particolari, la nostra fazione, l’ordine di scuderia e diventare semplici cittadini? Non merita forse la nostra attenzione, il nostro incondizionato impegno, la nostra battaglia, quella tutela della salute di cui a parole ci ergiamo a paladini?
Ascoltando i tanti commenti che si levano nei più svariati consessi, emerge un chiaro e triste segnale che essa – la tutela della salute -, non è un fine, bensì un mezzo per apparire, una vetrina in cui esporre le proprie “medaglie”, che sono l’organizzazione del tal convegno, la realizzazione della tale rete e, perché no, “l’ideazione” del tal evento.
Quando da queste stesse pagine, nel maggio scorso, lanciai un appello affinché ci si unisse, tutti, al di là delle appartenenze, affinché coloro che condividevano l’urgenza di una battaglia collettiva in difesa del diritto alla salute, non tanto volto a scuotere qualche coscienza “in alto”, quanto a fare ingrossare le fila “in basso”, tra i cittadini, innumerevoli sono stati i contatti, gli inviti a parlare e ad ascoltare. Ogni associazione, rete, comitato era fieramente desiderosa di mostrare il proprio operato, ma ognuna voleva apporre il proprio “sigillo”, collocandosi ben lontana dallo spirito di quel mio articolo che, citando Hannah Arendt, propugnava un essere accanto all’altro, non sopra o altrove.
Ho sempre pensato che in questo nostro Paese circolasse troppo testosterone e pochi estrogeni, ne sono ancora convinta, ma ho dimenticato di aggiungere un attributo: estrogeni “di qualità”. Serve insomma che si lasci emergere la parte migliore della cittadinanza – che certo non è solo femminile -, la quale si colloca tra quanti non appaiono nella forma, ma nella sostanza, e nelle corsie come nelle scuole, nelle redazioni o in qualsiasi altro luogo di lavoro, olia gli ingranaggi arrugginiti di un Paese sempre più distante dai bisogni della gente.
Troppi sono i medici che ogni giorno vedono progressivamente svilirsi la loro missione, troppi anche quei 9 milioni di cittadini che hanno dovuto rinunciare a curarsi per mancanza di denaro. E la schiera rischia di infoltirsi ancora, anche per serie patologie.
Il “Decreto Balduzzi”, nato con l’intento di rendere immediatamente disponibili importanti farmaci approvati dall’EMA [European Medicines Agency, N.d.R.], ha permesso che antitumorali come il Pertuzumab e l’Anfilbercept possano essere messi in vendita prima del pronunciamento dell’AIFA [Agenzia Italiana del Farmaco, N.d.R.] e, dunque, a diretto carico dei pazienti, per una cifra che può raggiungere i 1.000 euro a settimana. In questa nuova sterzata, inutile dire che molte donne – di nuovo in prima linea nelle loro famiglie per far fronte ai problemi derivati dalla crisi – subiranno il contraccolpo più duro. Per questo non sarebbe male se alcune tra loro, le più fortunate, quelle che possono vantare una posizione che permette loro di rendere efficaci e proficue le proprie azioni, se ne facessero carico, piuttosto che pensare a lustrare la propria vetrina.
Non possiamo continuare ad ignorare l’enorme potenziale femminile, nello studio come nel lavoro, che perdiamo ogni anno, perché di fronte alla necessità di assistere i figli, un parente disabile o non autosufficiente, un genitore anziano, un malato, lo Stato latita e con esso i servizi. Non resta allora che aprire per l’ultima volta il cassetto per riporvi i sogni, le aspirazioni, e tutte quelle sane ambizioni che arricchirebbero ciò che un tempo ormai lontano si chiamava capitale, non finanziario bensì umano.
Viviamo immersi in un mondo di numeri che ci paralizzano perché traducono perdite: di lavoro, di sicurezza, di futuro. Sono cifre, quelle che ci vengono propinate, per convincerci a dire: «Bye bye welfare»!. Eppure ci sono studi, altre cifre, che nei media tradizionali vengono sistematicamente omesse o lasciate scivolare nelle notizie brevi, mentre se fossero poste nel giusto rilievo ci spingerebbero in ben altra direzione.

Mi riferisco, ad esempio, all’analisi coordinata da Andrea Ciarini [dell’Università La Sapienza di Roma. Il riferimento è al recente studio promosso dalla Rete “Cresce il welfare, cresce l’Italia”, di cui si legga ampiamente anche nel nostro giornale, N.d.R.] che mette in evidenza come in Europa, nel quinquennio 2008-2012, mentre nel manifatturiero si perdevano oltre 3 milioni di posti di lavoro, welfare, cura e assistenza ne generavano un milione e 623.000.
Ma penso anche a notizie come la bocciatura – meritatissima – incassata dal nostro Paese da parte della Corte di Giustizia Europea, per non aver «messo in atto misure efficaci ed appropriate per un effettivo inserimento professionale delle persone con disabilità».
In Italia, secondo i dati della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap), la percentuale degli occupati tra i disabili di età compresa tra i 15 e i 74 anni è di appena il 16%, contro il 49,9% della popolazione normodotata, e soprattutto contro quel 50% di disabili inseriti nel mondo del lavoro in Gran Bretagna, dove l’investimento pro capite è di 754 euro contro i 430 dell’Italia.
L’aria che si respira non permette che ci sia più spazio per indifferenza e rassegnazione perché quando in gioco c’è la vita, il silenzio è sempre colpevole. Ce lo ricorda l’appello accorato di una madre al Presidente della Repubblica, supplicandolo di intervenire per evitare la chiusura di una casa famiglia che sua figlia e qualche decina di altri ragazzi frequentano da molti anni, trovando lì, ogni giorno, quella parte di socialità che è consentito loro di esprimere.
Lo racconta a «la Repubblica» Silvia di Milano. Figlia di un malato di Alzheimer, dopo cinque anni passati a seguire il padre, non ce l’ha fatta. È crollata ed è finita in analisi perché «nessuno ti aiuta, le poche strutture costano migliaia di euro e sembrano brutte prigioni».
Ce lo rammentano quei genitori che, disperati, supplicano i professori di bocciare i loro figli disabili perché chiusa la parentesi scolastica c’è il vuoto. I ragazzi restano chiusi tra le quattro mura domestiche senza alcuna prospettiva, sebbene la disabilità precluda delle scelte, ma non tutte. Adeguatamente supportato, infatti, ciascuno di loro potrebbe condurre una vita dignitosa e contribuire al progresso proprio e del Paese. Eppure quell’“adeguatamente” è ancora un miraggio nel deserto della solitudine con cui famiglie, disabili, anziani, non autosufficienti sono costretti a confrontarsi ogni giorno. Ma cos’è il diritto alla salute senza l’inclusione sociale?
Ci preoccupiamo ogni giorno di diventare un Paese povero, dovremmo piuttosto considerare quanto stiamo diventando un povero Paese. I problemi da affrontare, e la sanità non fa eccezione, non sono tanto i tagli – pur gravi e spesso insopportabili – quanto la mancanza di prospettive, di programmazione, di proposte valide, di quella passione che trasforma la rabbia in progetti, e soprattutto di una idea di futuro.
Che Stato vogliamo? Questa è la domanda a cui dobbiamo rispondere. Vogliamo ancora proseguire sulla strada suicida che vede il capitale eretto a religione, oppure siamo disposti ad essere tutti un po’ più poveri per diventare un Paese ricco? La domanda non è un ossimoro, ma sintetizza una visione laica di ricchezza di valori, di attenzione al prossimo, alle minoranze, alle diversità. Traduce una visione di sanità che significa affiancamento del paziente in tutte le fasi della sua malattia, mettendo sempre lui – la persona – e non la cosa, la malattia – al primo posto.
Una sanità che non significa “manutenzione”, ma attenzione, perché il corpo è sì un insieme di cellule, ma ancor più è una vita con il suo pensiero, i suoi sentimenti, i suoi slanci, le sue vittorie e le sue sconfitte.
Ancora una volta, a tirare le orecchie a una politica sorda, cieca e assolutamente inadeguata, è la Magistratura contabile che ricorda – a chi ha la memoria corta e usa qualunquistiche visioni sulla spesa pubblica come strumento per far passare manovre che non mettono mano laddove dovrebbero – che il problema non è la spesa sanitaria – sotto controllo – ma il rischio che non si riesca ad assicurare un’adeguata garanzia dei livelli di assistenza.
Sottolinea il procuratore generale Salvatore Nottola che «le criticità del sistema sanità sono tali che esso non riesce a fornire un servizio soddisfacente» perché «permangono irrisolte le problematiche relative alle liste di attesa; al funzionamento dei pronti soccorso, spesso in difficoltà; alla sostenibilità di elevati livelli di compartecipazione di spesa (tickets); alle ancor pur numerose fattispecie di danni erariali».
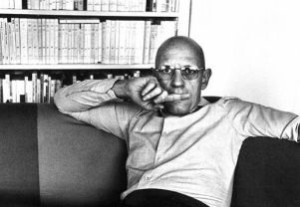
E a proposito di erario, è il caso di aprire una riflessione sull’idea che si sta diffondendo da alcuni anni, prendendo spunto dal Libro Bianco sul futuro del modello sociale, La vita buona nell’età attiva, pubblicato nel 2009 dall’allora ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, Maurizio Sacconi, che non si possa più garantire tutto a tutti (universalismo selettivo), ma che al massimo si debba pensare solo ai più bisognosi. Dunque un’idea di sanità legata al concetto di carità, che rappresenta un balzo indietro di oltre un secolo e che, in uno Stato dove si stimano per difetto 180 miliardi di evasione fiscale l’anno, rischia di premiare gli evasori a scapito dei cittadini onesti, almeno fino a quando il bisognoso lo si qualifica tale da un’autocertificazione.
Stiamo perdendo pezzi di diritti conquistati a prezzo di dure battaglie e li guardiamo scivolare via attoniti, inebetiti, trincerati dietro l’alibi della crisi economica. Essa c’è, è innegabile, ma non è la causa, almeno non la sola. Prima ancora di perdere l’oggetto del diritto, ne abbiamo perso il senso. Ed è questo che dobbiamo recuperare, subito. Poi, possiamo dedicarci a ripulire la sanità dalle tante storture, dagli sprechi, dal malaffare. Gli spazi di manovra per risparmiare senza tagliare i servizi ci sono – basti pensare ai 12 miliardi drenati dalla cosiddetta “medicina difensiva”, o ai 15 succhiati da sprechi e inefficienze o, ancora, ai 14 miliardi che secondo una ricerca del Politecnico di Milano si possono recuperare attraverso la digitalizzazione di tutto il sistema.
C’è molto di cui occuparsi in sanità, ma questo dev’essere l’impegno di tutti, senza personalismi. Era ed è questo il senso del mio appello del maggio scorso, il cui scopo, attraverso l’organizzazione di un’ideale catena umana, in occasione dei trentacinque anni dalla promulgazione della Legge 833/78, con cui si è istituito il Servizio Sanitario Nazionale, consiste nel rendere visibile una ritrovata compartecipazione dei cittadini per la salvaguardia dei diritti fondamentali perché, come scrive Michel Foucault ne La cura di sé, «il punto di Archimede sul quale posso da parte mia sollevare il mondo è la trasformazione di me stesso». Cominciamo a farlo ripulendoci dagli egoismi e dalle manie di protagonismo, per ritrovare il piacere che nasce dalla condivisione, dalla collaborazione, dall’impegno per e con gli altri, perché la salute è di tutti e la sanità è per tutti.
Giornalista e scrittrice, vincitrice del Premio Nazionale Informazione per la salute 2013 al Festival Internazionale del giornalismo di Perugia. Il presente testo appare anche in «Quotidiano Sanità», con il titolo “La sanità, i diritti perduti e un Paese smarrito” e viene qui ripreso, per gentile concessione, con alcuni riadattamenti al diverso contenitore.
Articoli Correlati
- Il Disegno di Legge Zan e la disabilità: opinioni a confronto Riceviamo un testo dal sito «Progetto Autismo», a firma di Monica Boccardi e Paolo Cilia, che si riferisce, con toni critici, a un contributo da noi pubblicato, contenente due opinioni…
- L'integrazione scolastica oggi "Una scuola, tante disabilità: dall'inserimento all'integrazione scolastica degli alunni con disabilità". Questo il titolo dell'approfondita analisi prodotta da Filippo Furioso - docente e giudice onorario del Tribunale dei Minorenni piemontese…
- Intervista doppia su disabilità e dintorni Due esperienze di vita a confronto, due generazioni diverse che parlano di disabilità e di tutto ciò che ruota intorno ad essa, dalle emozioni più personali alle grandi questioni come…

