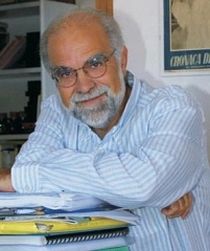 È certamente uno dei più importanti sceneggiatori italiani, Stefano Rulli, del quale basterà ricordare il lavoro per film noti come Mery per sempre, Il portaborse, Il ladro di bambini, Pasolini. Un delitto italiano, Vesna va veloce, La tregua, I piccoli maestri, La meglio gioventù, Le chiavi di casa e Romanzo criminale, senza dimenticare serie televisive di successo come La piovra, Uno bianca o Perlasca. Un eroe italiano.
È certamente uno dei più importanti sceneggiatori italiani, Stefano Rulli, del quale basterà ricordare il lavoro per film noti come Mery per sempre, Il portaborse, Il ladro di bambini, Pasolini. Un delitto italiano, Vesna va veloce, La tregua, I piccoli maestri, La meglio gioventù, Le chiavi di casa e Romanzo criminale, senza dimenticare serie televisive di successo come La piovra, Uno bianca o Perlasca. Un eroe italiano.
Incontrare Rulli – che nel corso della sua carriera ha affrontato in più di un’occasione il tema della disabilità psichica – è stato un grande privilegio.
Le nostre domande e le relative risposte sono divise in due parti principali, la prima riguardante il percorso intrapreso negli anni in ambito di integrazione, la seconda il linguaggio cinematografico.
Alcune parole chiave
Forse, per aiutare i lettori a capire meglio una serie di riferimenti presenti in questa lunga intervista, è opportuno fornire alcune “parole chiave”.
– Matti da slegare
Documentario del 1975 diretto da Rulli con Silvano Agosti, Marco Bellocchio e Sandro Petraglia sui primi esperimenti di inserimento sociale di disabili psichici.
– Sto lavorando
Documentario del 1998 di Daniele Segre sull’esperienza di integrazione lavorativa di Matteo Rulli all’interno di un ristorante.
– Un silenzio particolare
Documentario diretto da Rulli nel 2004 sulla sua famiglia e in particolare sul figlio Matteo e sulla casa vacanze “La città del sole”.
– Le chiavi di casa
Film del 2004 di Gianni Amelio, con Kim Rossi Stuart, Charlotte Rampling e Andrea Rossi, sceneggiato da Rulli con Sandro Petraglia e basato sul libro di Giuseppe Pontiggia Nati due volte.
– Nati due volte
Romanzo di Giuseppe Pontiggia – come già detto – sulla propria esperienza con il figlio Andrea, disabile psichico.
– “La città del sole”
Casa per le vacanze in Umbria voluta da Rulli con la moglie e scrittrice Clara Sereni, in grado di accogliere persone con disabilità fisica e psichica. È sostenuta dall’omonima Fondazione.
Nel 1975 la sua carriera inizia con Matti da slegare, documentario sui primi esperimenti alternativi agli ospedali psichiatrici. Nel 2004 dirige Un silenzio particolare, ancora sul disagio psichico e sceneggia il film Le chiavi di casa. Non potevamo non intervistarla…
«Già, strani casi della vita. Matti da slegare mi ha introdotto al linguaggio del cinema e alla realtà sociale dei malati di mente: due scoperte che avrebbero segnato la mia vita. La prima, infatti, mi ha avviato al mestiere di sceneggiatore, l’altra l’avrei di lì a poco reincontrata con la nascita di mio figlio Matteo, disabile psichico. Ma mentre Matti da slegare è una denuncia politico-sociale, l’esperienza con Matteo ha fatto crollare le mie ideologie e perciò Un silenzio particolare ha un tono diverso.
Quando con mia moglie Clara Sereni subiamo emarginazioni legate a Matteo, scegliamo di non giudicare la società come insensibile, ma di capire che la malattia mentale fa paura: più che denunciare l’insensibilità degli altri, è utile aiutarli a capire. Un silenzio particolare è un diario privato che invita i “normali” a guardare con meno apprensione la vita di una famiglia “diversa”».
L’aver girato Matti da slegare è servito quando è nato Matteo? «No, non rispetto al dolore. È un’esperienza da vivere fino in fondo, a cui trovare risposte personali. All’inizio mi sentivo in colpa per aver fatto “qualcosa di imperfetto”, un atteggiamento che non ha ragion d’essere culturale o politica.
«No, non rispetto al dolore. È un’esperienza da vivere fino in fondo, a cui trovare risposte personali. All’inizio mi sentivo in colpa per aver fatto “qualcosa di imperfetto”, un atteggiamento che non ha ragion d’essere culturale o politica.
La cultura e la politica non aiutano a capire cosa ti aspetti, cos’è la tua idea di normalità. Volevo che Matteo imparasse a scrivere perché la mia idea di normalità è la scrittura, fossi muratore avrei voluto imparasse a usare le mani.
Ho sofferto finché mi sono accorto che l’idea di normalità di Matteo – che ha imparato a scrivere per farmi piacere – è diversa dalla mia. Dev’essere lui ad individuare abilità interne al suo bisogno.
Poi non ho più nemmeno cercato un punto da raggiungere, una soglia di normalità: mi sono concentrato sul viaggio, se una persona viaggia o sta ferma. L’importante è l’obiettivo raggiunto oppure per quale processo di cambiamento si è passati? Matteo ha fatto un lunghissimo viaggio. Da piccolo, se uscivo dalla stanza, per lui era come se fossi morto e dovevo continuare a parlare. Adesso vive senza genitori e un paio d’anni fa è stato in Chiapas con un amico, trentasei ore in aereo e un mese lì. C’è stata una fase in cui “accettavo Matteo”, ora ne sono orgoglioso: è una sensazione diversa».
Il passaggio da Matti da slegare a Un silenzio particolare coincide con il suo percorso interiore. C’entrano anche le diverse realtà politico-sociali di riferimento?
«Certo. Oggi Matti da slegare non avrebbe senso perché alcuni princìpi per i quali si combatteva allora sono acquisiti, ma ci sono segregazioni più sottili: il disabile mentale può inserirsi, ma solo tramite un accompagnatore che, delegato a gestire il rapporto con lui, diventa a sua volta emarginato.
Oggi dovremmo lavorare sui contesti di vita “normali”, perché diventino così vivibili da accogliere i “diversi” senza mediazione. Quando la nostra Fondazione “La città del sole” conduce un’esperienza di integrazione lavorativa, un coordinatore sociale e uno psichiatra accompagnano l’inserimento, ma poi, nella quotidianità, i lavoratori sperimentano il contatto emotivo con il disabile psichico senza intermediari, imparano a gestirlo in autonomia. Ed è una conquista anche per loro».
In Matti da slegare c’è già un discorso simile nella parte sull’inserimento in fabbrica di alcune persone con sindrome di Down…
«Esatto. Ma lì mostravamo un caso particolare, riferito a una realtà politicizzata e consapevole. A livello diffuso le situazioni sono più complicate. Matteo è stato di recente spostato in un settore dove i lavoratori, che aspettavano da tempo una risorsa umana in più, hanno reagito male al suo arrivo. La nostra Fondazione si è confrontata con loro e li ha invitati a separare i problemi: Matteo ha diritto a lavorare come lavoratore con borsa lavoro, altro discorso è la richiesta sindacale di un lavoratore in più, che possiamo condividere. Dopo questo chiarimento il clima è cambiato: la mediazione culturale è indispensabile per l’integrazione (quando un corpo unico reintegra una parte di sé e la riaccetta). La “parte fragile” della comunità è stata esclusa e la comunità può recuperarla solo se è così adulta da poterla accettare. Il lavoro sui contesti vale anche per la residenzialità. Se chi ha un disagio psichico abita solo con chi ha problemi simili, rischia l’autoemarginazione. “La città del sole” gestisce alcuni appartamenti dove convivono persone con problemi diversi. Matteo abita con studenti fuori sede, ragazze madri, extracomunitari. A loro si chiede, in cambio dell’utilizzo gratuito della casa, di dedicare due giorni alla settimana a Matteo, che così vive tra giovani, non in un gruppo “speciale”. Ciascun inquilino porta in casa gli amici e se c’è un concerto invitano anche Matteo: è interesse di tutti che quella funzioni come una casa vera, perché ci devono vivere».
Il lavoro sui contesti vale anche per la residenzialità. Se chi ha un disagio psichico abita solo con chi ha problemi simili, rischia l’autoemarginazione. “La città del sole” gestisce alcuni appartamenti dove convivono persone con problemi diversi. Matteo abita con studenti fuori sede, ragazze madri, extracomunitari. A loro si chiede, in cambio dell’utilizzo gratuito della casa, di dedicare due giorni alla settimana a Matteo, che così vive tra giovani, non in un gruppo “speciale”. Ciascun inquilino porta in casa gli amici e se c’è un concerto invitano anche Matteo: è interesse di tutti che quella funzioni come una casa vera, perché ci devono vivere».
Spesso i film sulla disabilità cadono nella cosiddetta “sindrome di Lavazza”: per superare cioè un senso di colpa rispetto al disabile, lo raccontano come migliore degli altri. Non crede che questa sia una soluzione discriminatoria che rifiuta l’analisi della complessità?
«Spesso sento dire che le persone disabili sono una “benedizione” e i loro genitori sono “straordinari”: tutta retorica che nasconde un giudizio, “ti do la patente di eroe però tu stai di qua e io di là“.
Il commento più bello al mio film è: “Mi ha fatto male perché descrive ciò che faccio con mio figlio”. Vuol dire che Matteo esplicita qualcosa di più universale della malattia, come il rapporto conflittuale padre-figlio, bisognoso di rassicurazioni e desideroso di separazione».
Un silenzio particolare rende la complessità senza giudizio, Matti da slegare aveva già questa impronta. Secondo noi, invece, Le chiavi di casa di Gianni Amelio, da lei sceneggiato, questa complessità non la rende…
«Le chiavi di casa ha grandi meriti per la scelta del soggetto. Non riesco a giudicare, posso solo dire che nei documentari costruisco mentre giro e non so quello che verrà fuori, mentre in una sceneggiatura è tutto pensato prima».
Anche Sto lavorando di Daniele Segre, che descrive un’esperienza di integrazione lavorativa di Matteo, ha un linguaggio simile a quello dei suoi documentari.
«Sono grato a Daniele Segre. Sto lavorando è nato anche per disperazione. Matteo aveva trovato il suo primo lavoro per tre mesi in un ristorante, un’esperienza così straordinaria che abbiamo detto: la dobbiamo “fermare”, se la raccontiamo solo a parole, nessuno ci crede. Si tratta di uno dei pochi documenti sull’integrazione lavorativa di uno psicotico. Dopo che questo film ha riscosso un buon successo, Matteo è rimasto nel ristorante per altri quattro anni».
Vi sono alcune esperienze – e facciamo riferimento in particolare a quelle condotte dalla redazione di «DM», il giornale della UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) – che fanno pensare come nel cinema, e specie in quello d’animazione, la risata possa aiutare a riflettere su temi delicati. La già citata redazione di «DM», ad esempio, ha proposto il cartone Vip mio fratello Superuomo di Bruno Bozzetto in alcune scuole superiori, suscitando molta attenzione negli studenti…
«A volte il pubblico è imbarazzato a ridere al mio film: la falsa seriosità (per cui si teme che la comicità sulla diversità sia “razzistica”) genera distanza. Invece una risata può evitare la retorica, a patto che non scada nella caricatura e sia profonda e seria, come in Elling, un recente film norvegese di Petter Naess».
*Testo tratto dal numero 157 di «DM», periodico nazionale della UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) e qui riprodotto, per gentile concessione di tale testata.
Articoli Correlati
- Solo Stefano Rulli poteva dirigere «Un silenzio particolare» Il film - documentario della storia di una famiglia, di un figlio problematico e di una casa vacanze - è stato appunto diretto dal noto sceneggiatore di pellicole come "Mery…
- Che cosa sono le nuvole? È il titolo di uno dei due mosaici inaugurati nei giorni scorsi alla Scuola Media Pasolini di Pordenone e realizzati dai ragazzi dell'istituto assieme ad alcune persone con autismo, bell'esempio…
- Donne con disabilità e violenza: diventi una Linea Guida quell’ottimo rapporto Il recente rapporto “Il Punto – Il pregiudizio e la violenza contro le donne” contiene un capitolo sulla violenza nei confronti delle donne con disabilità, elaborato in modo particolarmente apprezzabile,…

