 Compiono dai settanta agli ottant’anni, ma non li dimostrano. Le Silly Symphonies, a lungo dimenticate dalla critica e riscoperte da meno di vent’anni, rappresentano una delle parti più interessanti dell’intera filmografia disneiana. Si tratta di 73 cortometraggi d’animazione usciti dal 1929 al 1939, nei quali la musica (le “sinfonie pazzerelle”) e la ricerca formale grafico-pittorica non sono più al servizio esclusivo dei personaggi, ma diventano il perno attorno al quale far ruotare la storia.
Compiono dai settanta agli ottant’anni, ma non li dimostrano. Le Silly Symphonies, a lungo dimenticate dalla critica e riscoperte da meno di vent’anni, rappresentano una delle parti più interessanti dell’intera filmografia disneiana. Si tratta di 73 cortometraggi d’animazione usciti dal 1929 al 1939, nei quali la musica (le “sinfonie pazzerelle”) e la ricerca formale grafico-pittorica non sono più al servizio esclusivo dei personaggi, ma diventano il perno attorno al quale far ruotare la storia.
Le Silly Symphonies rappresentavano per Walt Disney una sorta di “compensazione culturale” ai cartoons delle “stelle di carta” Topolino, Minnie, Paperino, Pluto, Gambadilegno, incentrati esclusivamente sulle gag, sull’azione, cioè sul puro divertimento. Egli voleva, rimanendo saldamente ancorato all’idea di un prodotto fatto per il grande pubblico, riscattare il cartone animato da quel complesso d’inferiorità nei confronti non solo del cinema dal vero, ma in generale delle arti figurative. Intendeva insomma dimostrare che anche i cartoni animati, al pari di un classico della pittura, sono altrettanto capaci di infondere in un pubblico di massa l’emozione per la bella forma e l’edificazione morale.
Si può dire anzi che lo “stile Disney”, in cui la cura maniacale della verosimiglianza al mondo naturale si fonde con la natura antropomorfa degli animali, trovi a livello contenutistico il proprio corrispettivo oggettivo nell’apologo, nel racconto morale, al quale si rifanno quasi tutte le Silly Symphonies.
Non a caso i temi più ricorrenti dell’intera serie sono il rapporto tra l’individuo e il gruppo, il concetto di appartenenza/integrazione, l’accettazione della propria immagine e la scoperta di sé, l’handicap e lo svantaggio. Varianti, alla fin fine, di un unico tema, quello della diversità, uno dei tòpoi più ricorrenti del cinema disneiano, che cercheremo di analizzare in questa sede con l’aiuto di anatroccoli, elefanti e tori.
Come può farsi accettare un brutto anatroccolo?
Cominciamo mettendo a confronto le due versioni del Brutto anatroccolo (The Ugly Duckling), quella in bianco e nero del 1931 e quella in technicolor del 1939, la Silly Symphony che ha chiuso definitivamente la serie.
The Ugly Duckling (1931)
Nel pollaio si schiudono le uova della covata: nascono sei pulcini e da ultimo, un anatroccolo nero e spennacchiato al quale la chioccia impedisce da subito di integrarsi con i pulcini. L’azione si sposta poi nel prato per il primo pasto: l’anatroccolo scova un vermicello, ma i pulcini se ne appropriano senza nemmeno condividere il cibo con lui. Poi la chioccia, credendo che l’anatroccolo abbia malmenato i pulcini, lo caccerà con un ceffone. Anche gli altri animali si dimostrano nient’affatto solidali: una mucca e un cane lo respingono, una rana appena lo vede si tuffa dentro lo stagno. Disperato comincia a piangere e a questo punto avviene la svolta. Una tromba d’aria risucchia i pulcini e li scarica nel fiume; l’anatroccolo si tuffa a salvarli. La forte corrente sta trascinando tutti verso la cascata e quando non sembra esservi più scampo, ecco il colpo di fortuna: un piccolo mantice finito nel fiume consentirà all’anatroccolo di vincere la corrente e di restituire i pulcini alla chioccia che, felice, abbraccerà e riconoscerà l’anatroccolo al pari degli altri figli.
The Ugly Duckling (1939)
Vicino allo stagno si schiudono le uova covate da mamma anatra: dal nido usciranno quattro anatroccoli gialli. Mamma e papà anatra si baciano, quand’ecco uscire da un quinto uovo un’altra creatura, che però ha le piume bianche, è più grosso e non starnazza “delicatamente” come gli altri anatroccoli. Scoppia un litigio tra i genitori con accuse reciproche: il padre finisce per andarsene, la madre comincia a occuparsi degli anatroccoli. Il presunto anatroccolo li segue, ma mamma anatra e gli altri anatroccoli lo cacciano. Mentre se ne va fra gli sterpi, degli uccellini lo invitano a salire nel loro nido, ma la mamma giunta col cibo lo manderà via credendolo un ladruncolo. Poi nello stagno trova un’altra anatra, che però è di legno e ondeggiando lo picchierà col becco sulla testa. Il piccolo è dunque respinto da tutti e si dispera. Ma proprio quando tutto sembra perduto, ecco apparire la sua vera famiglia: dei piccoli cigni con la mamma che lo accoglierà sotto le sue grandi ali. Felice di avere scoperto la sua vera identità, nell’ultima scena si mostra orgogliosamente agli anatroccoli che lo salutano anch’essi felici.
Tralasciamo pure il confronto con la favola di Andersen e concentriamoci sui due protagonisti, il “brutto anatroccolo” (quello del 1931, testa nera con becco lungo, corpo spennacchiato somigliante a un pollo arrosto) e il “presunto anatroccolo” (quello del 1939, piumaggio bianco, tratti del corpo rotondi e graziosi, becco più corto e maggiormente proporzionato rispetto alla testa). In entrambi l’esclusione (lo “stigma” come avrebbe detto il sociologo Erving Goffman) si fonda sulla non appartenenza; nel primo caso l’anatroccolo non fa parte dell’ordine dei galliformi, nel secondo caso la discriminazione è addirittura su base familiare, dato che cigni e anatroccoli costituiscono due diverse famiglie dell’ordine degli anseriformi. Comunque, al di là delle distinzioni tassonomiche, il dato di partenza comune ai protagonisti delle due versioni è la negazione dell’identità, proprio nel senso letterale di escludere qualcuno per il semplice fatto di non ritenerlo somaticamente identico agli altri elementi del gruppo di nascita.
In entrambi l’esclusione (lo “stigma” come avrebbe detto il sociologo Erving Goffman) si fonda sulla non appartenenza; nel primo caso l’anatroccolo non fa parte dell’ordine dei galliformi, nel secondo caso la discriminazione è addirittura su base familiare, dato che cigni e anatroccoli costituiscono due diverse famiglie dell’ordine degli anseriformi. Comunque, al di là delle distinzioni tassonomiche, il dato di partenza comune ai protagonisti delle due versioni è la negazione dell’identità, proprio nel senso letterale di escludere qualcuno per il semplice fatto di non ritenerlo somaticamente identico agli altri elementi del gruppo di nascita.
Altro dato comune – che ritroveremo poi anche con riferimento al personaggio di Elmer – è la reazione nell’attimo in cui si rispecchiano nel laghetto: come in un “Narciso a rovescio”, i due anatroccoli, anziché innamorarsene, inorridiscono di fronte alla propria immagine, non deforme in sé, ma resa deforme dalle increspature dell’acqua. C’è però – ed è ciò che li unisce al mito greco di Narciso – l’attribuire uno statuto di realtà a un riflesso, che inevitabilmente conduce a una scissione interiore. L’impossibilità per Narciso di congiungersi, per gli anatroccoli di separarsi, da una copia immateriale scambiata per l’originale “se stessi”.
Diverso invece è il carattere che dimostrano i due anseriformi nell’affrontare il destino avverso. Nella prima versione la svolta è rappresentata da una calamità naturale, grazie alla quale l’anatroccolo ha l’occasione di dimostrare al gruppo: a) di essere coraggioso e disinteressato (senza pensarci due volte e soprattutto dimentico dei torti subiti, si tuffa immediatamente nel fiume per salvare i pulcini) e b) di avere un livello di astuzia e di intelligenza superiori, in grado di risolvere una situazione di emergenza in tempi rapidissimi (l’intuizione di utilizzare il mantice per vincere la corrente e come scialuppa di salvataggio).
Il premio sarà la trionfale riammissione, da parte della chioccia, nel gruppo da cui lei stessa lo aveva escluso. Ma quale modello di integrazione sottende la Silly Symphony del 1931? Non certo un’integrazione su base “identitaria”, poiché come si è visto, l’anatroccolo, oltre a rimanere brutto, rimane anatroccolo: non svela alcuna natura galliforme. Ciò che avviene è il riconoscimento di un ruolo e di una qualità morale: l’anatroccolo viene accolto per acclamazione come un leader, un “uomo della provvidenza” (senza dubbio più Roosevelt che Mussolini), fatto di decisionismo e di nobiltà d’animo. Potremmo definirla un’integrazione di tipo “meritocratico”: ti riconosco un’identità sociale perché te la sei guadagnata sul campo, perché hai dimostrato di avere gli “attributi”!
Nella versione del 1939, invece, il presunto anatroccolo è un rassegnato, senza particolari slanci. Si sente una vittima senza credere in una possibilità di riscatto sociale. Non è certo un'”uomo della provvidenza”, caso mai, al contrario, sembra confidare nella provvidenza, che (può non essere così?) lo ripagherà di tutte le sue sofferenze facendogli incontrare i suoi veri simili (i cigni).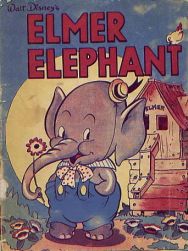 Nella sequenza finale gli anatroccoli lo guardano contenti, lui si gira voltando loro le spalle come se dicesse: «Avete visto?! Ce l’ho fatta anch’io a trovare il mio posto». Lui è fiero di aver trovato la sua vera famiglia, ma anche gli anatroccoli, dopo averlo trattato in malo modo, sono felici che l’abbia trovata: l’importante – questa sembra essere in controluce la morale del remake del 1939 – è che ognuno stia nel proprio recinto sociale.
Nella sequenza finale gli anatroccoli lo guardano contenti, lui si gira voltando loro le spalle come se dicesse: «Avete visto?! Ce l’ho fatta anch’io a trovare il mio posto». Lui è fiero di aver trovato la sua vera famiglia, ma anche gli anatroccoli, dopo averlo trattato in malo modo, sono felici che l’abbia trovata: l’importante – questa sembra essere in controluce la morale del remake del 1939 – è che ognuno stia nel proprio recinto sociale.
Contrariamente dunque all’anatroccolo del 1931, l’inclusione tra i cigni avviene su base paritaria, senza condizioni, a prescindere dall’aver dimostrato doti particolari. Ma non vi è alcuna forma di integrazione, dato che gli anatroccoli devono stare con gli anatroccoli, i cigni con i cigni. Insomma, la garanzia della pace sociale è la separazione di ogni gruppo/famiglia di animali all’interno della comunità.
In altre parole, il “brutto anatroccolo” ha diritto di cittadinanza per ciò che fa, per aver dimostrato, in quanto diverso, di essere migliore degli altri; potremmo dire: anziché “diversamente abile” ha dimostrato di essere maggiormente abile. Nel “presunto anatroccolo”, invece, il diritto di cittadinanza gli è concesso per ciò che è, cioè su base identitaria, ed è concesso dai cigni, non dagli anatroccoli: guai, infatti, a nascere nel posto sbagliato!
In entrambi i casi, però, ne esce sconfitta l’idea di persona, la concezione del Cittadino nata dalla Rivoluzione Francese, quale titolare di diritti per il semplice fatto di esistere, indipendentemente dal luogo di nascita e/o dalle proprie abilità.
Da Elmer a Dumbo
Prendiamo ora in esame un altro aspetto dell’esclusione, quella fondata sul corpo e sull’aspetto fisico: diversità più di tipo freak. Passiamo in questo dagli anseriformi ai pachidermi e mettiamo anche qui a confronto due piccoli elefanti: Elmer (Elmer Elephant, 1936) e Dumbo (Dumbo, 1941), che pur non facendo parte del ciclo delle Silly Symphonies, costituisce una filiazione/evoluzione del personaggio di Elmer.
Elmer Elephant (1936)
Durante la festa di compleanno della tigrotta Tillie, Elmer riscuote le simpatie della festeggiata per averle regalato dei fiori. Gli altri animali però non gradiscono: sbeffeggiandolo per la lunghezza della proboscide, lo cacciano a calci e spintoni. Affranto, Elmer cerca in tutti i modi di nascondere la proboscide, quando un’anziana giraffa gli fa notare che anche lei viene presa in giro a causa del collo. E anche i pellicani a causa del loro becco. Poi la giraffa nota lo scoppio di un incendio nella casa di Tillie. Elmer si precipita, e con l’aiuto della giraffa e dei pellicani, riuscirà con la tanto vituperata proboscide a spegnere l’incendio e a trarre in salvo la tigrotta, conquistandosi sia l’amata che l’ammirazione degli animali che l’avevano emarginato.
Dumbo (1941)
Atteso da tanto tempo, Dumbo l’elefantino dalle orecchie ipertrofiche sulle quali continua a scivolare, rovina involontariamente uno spettacolo mandando all’aria il circo. Riceverà una doppia punizione: l’organizzazione lo declassa al rango di clown, mentre la propria specie lo ripudia per indegnità. Il povero Dumbo, già privato della mamma rinchiusa in gabbia come pazza, fugge dal circo e dopo un lungo sogno si risveglia sopra il ramo di un albero in compagnia di un gruppo scanzonato di corvi. Con il loro aiuto e del fido topo Timothy, imparerà a volare, scoprendo la potenzialità nascosta proprio in quelle orecchie che da fenomeno da baraccone lo faranno diventare la massima attrazione del circo.
La proboscide di Elmer, più che una vera e propria deformità fisica, è il pretesto da parte degli altri animali per attaccare – prima con la derisione poi con la violenza “bullistica” da branco – l’adolescente timido e provinciale che ha ricevuto un’attenzione in più dalla ragazzina contesa un po’ da tutti. L’umiliazione spinge Elmer a tentare di nascondere la proboscide, se potesse la taglierebbe. Poi la prova, è il caso di dirlo, del fuoco, che gli farà scoprire in modo pieno il proprio corpo e le proprie potenzialità, ridandogli l’autostima perduta.
La scoperta di sé è per Elmer semplicemente la scoperta di quello che tutti gli elefanti sanno fare, cioè usare la proboscide; è la metafora dello sviluppo della personalità di un adolescente proiettato verso l’età adulta. Come l’anatroccolo del 1931, egli si conquista per via meritocratica il proprio posto nella società (ben inteso per entrambi, senza metterne minimamente in discussione le regole!). Diversamente però dal “collega” anseriforme, Elmer scopre – nel mettersi alla prova – di essere semplicemente come gli altri pachidermi, capace cioè di saper sfruttare la proboscide per aspirare e gettare acqua. Dimostra coraggio, ma non un acume particolare, è insomma un “piccolo-borghese” in nuce. Il suo lo potremmo definire il passaggio dalla disabilità alla (passatemi il termine) normabilità. Il viaggio di formazione sentimentale di Dumbo, invece, è più complesso. Innanzitutto egli appartiene a una “classe” subalterna, nel senso che gli elefanti, come gli altri animali del circo, sono degli sfruttati. Purtroppo, però, la condizione di sfruttamento non sempre fa nascere in chi vi soggiace una mentalità libera da pregiudizi nel nome della solidarietà tra esclusi: la falsa coscienza di chi è oppresso, senza averlo realizzato, porta l’individuo a incanalare la propria rabbia nella direzione non di combattere, ma di riprodurre il sistema oppressivo su qualcun altro più svantaggiato.
Il viaggio di formazione sentimentale di Dumbo, invece, è più complesso. Innanzitutto egli appartiene a una “classe” subalterna, nel senso che gli elefanti, come gli altri animali del circo, sono degli sfruttati. Purtroppo, però, la condizione di sfruttamento non sempre fa nascere in chi vi soggiace una mentalità libera da pregiudizi nel nome della solidarietà tra esclusi: la falsa coscienza di chi è oppresso, senza averlo realizzato, porta l’individuo a incanalare la propria rabbia nella direzione non di combattere, ma di riprodurre il sistema oppressivo su qualcun altro più svantaggiato.
Come per Elmer, il punto di partenza è rappresentato dall’equazione deformità = disabilità, essere cioè ritenuto dai propri simili non-abile a esibirsi, in un modo considerato in fin dei conti innaturale e umiliante anche dagli stessi elefanti, ma da essi subìto senza contestazioni.
Quando Dumbo inciampando sulle orecchie, che pure aveva tentato di nascondere, franerà su tutti gli elefanti provocando con un effetto domino la distruzione del circo, verrà doppiamente punito. La prima sanzione gli deriva dall'”istituzione” circo, che declassa il piccolo pachiderma al rango di clown. E qui va ricordato che nella gerarchia del circo i clown ricoprono il gradino più basso, poiché far ridere è considerata un’azione deprecabile, roba “da bassi istinti”, tollerata solo perché funzionale allo spettacolo. Gli stessi clown, privi della facciata di dignità degli elefanti, sono rappresentati come gente senza troppi scrupoli, capaci per denaro di utilizzare Dumbo, che non ha ancora scoperto di saper volare, in un numero molto pericoloso e che in più lo ridicolizza.
Da qui deriva la seconda e più bruciante sanzione inflittagli dalla sua stessa “classe”. Gli elefanti, anziché cogliere la portata “rivoluzionaria” del gesto di Dumbo – certamente involontario e non premeditato, ma che aveva comunque “colpito al cuore il sistema” – decidono di disconoscerlo, giudicandolo dopo il numero con i clown indegno di appartenere agli elefanti: un atteggiamento di totale subalternità ai “padroni del tendone”.
Ed ecco la seconda nascita di Dumbo. Dopo la notte in cui è nato, un’altra notte segna il passaggio a una nuova vita: al termine del sogno (la meravigliosa sequenza cui pare abbia collaborato Salvador Dalì), si ritrova sopra un ramo e con l’aiuto dei corvi e di Timothy imparerà a volare. A differenza di Elmer, la scoperta di sé non è solo un’”ordinaria” acquisizione di autostima: la “metamorfosi” di Dumbo è innanzitutto prendere coscienza di essere “altro”, di essere dotato di un’irriducibilità sia ai pachidermi che ai volatili; è il passaggio dalla disabilità al senso di una diversa abilità. Dumbo si emancipa, ma non si omologa, ritorna nel “sistema circo”, ma con spirito indipendente. Diventa sì una “star”, ma non l'”uomo della provvidenza”.
Al contrario di Elmer e degli anatroccoli – che in ciò avevamo accomunati a Narciso – Dumbo non crede ad alcuna immagine riflessa, non scopre con orrore di avere delle orecchie grandi da una pozza d’acqua: lo sa già fin dalla nascita e lo sperimenta quotidianamente inciampandovi. La scoperta del proprio potenziale è rivelazione di una soggettività che, in quanto unica e irriducibile, non necessariamente ha bisogno di relazionarsi con gli altri. Dumbo riprende da Narciso il piacere di una soggettività beata, autonoma, non bisognosa d’altro. Un “Narciso liberato”, però, non più schiavo di quella logica del rispecchiamento che condurrà alla morte il bellissimo giovane per essersi riconosciuto come mero riflesso, riflesso di nessun’altra realtà.
Qual è dunque il segno distintivo di Dumbo rispetto agli altri personaggi fin qui esaminati? Per tutti e quattro nascere “diversi” non equivale al percepirsi “diversi”, ognuno istintivamente si sente parte del gruppo in cui è nato; è il gruppo, o chi ne ha la tutela, che li fa sentire “diversi”. In Dumbo, però, il processo di liberazione è totale perché avviene nel segno sia di una radicale discontinuità/rottura con la propria specie, sia col “sistema-circo”. Certo, ritornerà a farne parte, ma d’altra parte Dumbo non è un personaggio che segue un’ideologia, non ha “sovrastrutture”: è semmai, come don Andrea Gallo ha detto di se stesso, un essere “angelicamente anarchico”.
Ferdinando il toro, un altro “angelo anarchico”
Anche il disegno animato con il quale si conclude questo breve viaggio nell’età dell’oro del “mago di Burbank” [così era soprannominato Walt Disney, N.d.R.], ha per protagonista un altro “angelo anarchico”: si tratta del toro Ferdinando (Ferdinand The Bull, 1938). A essere precisi il cortometraggio va annoverato tra gli “Special”, il primo di una serie che la Disney produsse con relativa regolarità fino agli anni Sessanta e poi sempre più saltuariamente fino agli anni Ottanta. Di fatto, però, Ferdinand The Bull è assimilabile al ciclo delle Silly Symphonies e come tale qui lo considereremo senza far troppo caso alle etichette.
Ferdinand the Bull (1938) Nella campagna vicino Madrid, il piccolo Ferdinando, anziché giocare alla lotta con gli altri torelli, preferisce starsene seduto ad annusare fiori all’ombra di una vecchia quercia da sughero. Passano gli anni e Ferdinando, cresciuto, conserva inalterata la sua passione. Un giorno arriva un gruppo di impresari decisi a scegliere un toro per la corrida: i coetanei di Ferdinando fanno di tutto per mettersi in mostra ed essere scelti, lui no. Sennonché, punto da un’ape, comincia a correre e a saltare come un indemoniato, facendo entusiasmare i cinque uomini. Suo malgrado sarà proprio lui a essere scelto per la corrida nell’arena di Madrid. Presentato come “el toro ferocio”, Ferdinando raggiunge il centro dell’arena e senza la benché minima intenzione di combattere, odora soavemente i fiori lanciati dal pubblico, facendo disperare fino alla pazzia il matador. Ferdinando verrà riportato a casa e all’ombra della sua amata quercia continuerà felice ad annusare i fiori.
Nella campagna vicino Madrid, il piccolo Ferdinando, anziché giocare alla lotta con gli altri torelli, preferisce starsene seduto ad annusare fiori all’ombra di una vecchia quercia da sughero. Passano gli anni e Ferdinando, cresciuto, conserva inalterata la sua passione. Un giorno arriva un gruppo di impresari decisi a scegliere un toro per la corrida: i coetanei di Ferdinando fanno di tutto per mettersi in mostra ed essere scelti, lui no. Sennonché, punto da un’ape, comincia a correre e a saltare come un indemoniato, facendo entusiasmare i cinque uomini. Suo malgrado sarà proprio lui a essere scelto per la corrida nell’arena di Madrid. Presentato come “el toro ferocio”, Ferdinando raggiunge il centro dell’arena e senza la benché minima intenzione di combattere, odora soavemente i fiori lanciati dal pubblico, facendo disperare fino alla pazzia il matador. Ferdinando verrà riportato a casa e all’ombra della sua amata quercia continuerà felice ad annusare i fiori.
Il soggetto è tratto dal racconto per bambini The Story of Ferdinand (1936), scritto da Munro Leaf e illustrato da Robert Lawson. Ne è anzi una trasposizione così fedele, che se confrontiamo il testo e i disegni in bianco e nero del libro con il film, viene quasi da dire che gli autori della Disney si siano limitati ad aggiungere solo i colori!
Il libro esce nove mesi prima dello scoppio della Guerra Civile Spagnola: bollato per il messaggio pacifista, è ferocemente attaccato e poi bandito dai franchisti in Spagna e dai regimi nazifascisti europei. Si tratta invece di uno dei pochi libri, scritti da un non-comunista, ad essere diffuso dai sovietici durante l’occupazione della Polonia. Negli Stati Uniti venne anche utilizzato dai sostenitori anti-interventisti quando, all’indomani dell’attacco di Pearl Harbor, il governo americano decise di entrare in guerra.
Rivisto oggi decontestualizzato dalle vicende storiche, Ferdinand The Bull mantiene un’impronta libertaria alquanto inusuale e inusitata nel mondo disneiano. Oltre al messaggio pacifista, è una satira contro il “macho”, l’uomo forte e l’omofobia, che molto probabilmente non sarebbe stata prodotta in epoca maccartista, ma che sembra anticipare di trent’anni il movimento hippy.
C’è addirittura una gag che sembra direttamente ispirata da Tex Avery [l’animatore e regista statunitense creatore tra l’altro di Bugs Bunny e Daffy Duck, N.d.R.]. Dopo la sequenza introduttiva, viene inquadrata la mamma di Ferdinando; la voce off del narratore recita: «…a volte sua madre, che era una vacca, si preoccupava per lui…». Alla frase «che era una vacca» la mucca si gira, guarda in camera e scampanellando strabuzza gli occhi; poi, senza prendersela troppo, si reca dal figlioletto. Audace doppio senso, più unico che raro nella sterminata filmografia disneiana!
E tuttavia ciò che colpisce di più in questo corto del ’38 è la filosofia di vita di Ferdinando: rispetto ai personaggi precedenti, egli nasce e cresce senza alcun complesso di inferiorità, anche grazie a una madre che non cerca di cambiarlo, ma che vedendolo sereno, lo accetta così com’è. Non cerca un gruppo a cui integrarsi, non cerca occasioni per riscattarsi, è come gli piace essere. La sua scelta di felicità è un fatto congenito, istintivo, così naturale che non rinuncerà ad essere se stesso neanche quando si troverà al centro della corrida.
Un “Narciso liberato” fin dalla nascita, quindi, che diversamente da Dumbo, non ha nemmeno più bisogno di una liberazione.
*Testo apparso in «Rapporto Confidenziale», Rivista Digitale di Cultura Cinematografica, n. 18 e qui ripreso per gentile concessione.
– Umberto Curi, Il mito di Narciso, in Enciclopedia Multimediale delle Scienze Filosofiche (visionabile cliccando qui)
– Oreste De Fornari, Walt Disney, Milano, Editrice il Castoro, 1995
– Mariuccia Ciotta, Walt Disney. Prima stella a sinistra, Milano, Bompiani, 2005.
Articoli Correlati
- Da Pietro Gambadilegno a Dylan Dog e Gea Un excursus che parte dagli Anni Trenta del Novecento e da alcuni personaggi di Walt Disney, passando tra gli altri per Batman, Dick Tracy, Devil e gli X-Men, fino ad…
- Quando l’inglese fa rima con divertimento e inclusione Inclusione, divertimento e didattica, ovvero le tre parole chiave di “Disney English per Spazio Vita”, una bella iniziativa che prenderà il via domani, 20 ottobre, presso il Centro Polifunzionale Spazio…
- Quando la disabilità vola sulle “nuvole” di fumetti e cartoons Viaggio tra vignette, strisce e cartoni animati che narrano la vita quotidiana delle persone con disabilità. Da Gea e Leo alla campagna inglese “Creature Discomforts”, che coinvolge come doppiatori anche…

