 Valeria Coppola, ventotto anni, laureata in psicologia e giovane donna con disabilità motoria, ha realizzato una tesi di laurea all’avanguardia, che individua per la prima volta alcune difficoltà specifiche incontrate dai fratelli e dalle sorelle di persone con disabilità, in particolare nel periodo adolescenziale.
Valeria Coppola, ventotto anni, laureata in psicologia e giovane donna con disabilità motoria, ha realizzato una tesi di laurea all’avanguardia, che individua per la prima volta alcune difficoltà specifiche incontrate dai fratelli e dalle sorelle di persone con disabilità, in particolare nel periodo adolescenziale.
A partire dall’osservazione dei comportamenti del proprio fratello adolescente, di sei anni più giovane e normodotato, nel rapporto con la disabilità di lei, Coppola ha condotto uno studio sperimentale per approfondire alcune dinamiche specifiche del periodo dell’adolescenza, e cioè del periodo in cui il soggetto esce dal nucleo familiare e si inserisce in un gruppo di pari (la compagnia di amici coetanei).
Secondo le ricerche, condotte per mezzo di interviste a un campione di centoventi soggetti, risulterebbe che gli adolescenti che hanno un fratello o una sorella con disabilità sviluppano dei processi psicologici specifici che li differenziano dal gruppo dei pari, rispetto al quale si sentono diversi, esclusi, inadatti o superiori. Quindi, le funzioni di integrazione e condivisione del gruppo di pari non sono, in questo caso, svolte in modo completo.
Ed ecco la proposta originale della tesi, presentata per ottenere la laurea in psicologia e divenuta ora un libro edito da ESI (Edizioni Scientifiche Italiane): siccome il normale gruppo di amici coetanei in questo caso non è in grado di accogliere completamente l’adolescente fratello di una persona con disabilità, sarà utile creargli un gruppo “su misura”, nel quale l’identificazione possa essere completa. Il gruppo creato ad hoc, infatti, dovrebbe essere omogeneo, composto cioè solo da adolescenti fratelli o sorelle di persone disabili, e dovrebbe essere terapeutico, cioè condotto da un terapeuta che stimoli il confronto tra i partecipanti e l’analisi dei vissuti.
Si tratta di un’idea tanto semplice quanto nuova. L’unica esperienza avviata in Italia prima della tesi della Coppola era quella del sito internet Siblings.it, dove i fratelli si confrontano per via telematica. Ma l’incontro dal vivo coordinato da uno specialista non era ancora stato sperimentato. L’esperienza pilota è nata in Veneto, a Treviso, all’interno dell’ANFFAS locale (Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale), naturalmente su iniziativa della stessa Coppola.
Nell’intervista che la studiosa ha rilasciato a Superando, le chiediamo innanzitutto le età, sua e del fratello.
«Io ho ventotto anni e mio fratello Mariano ventidue anni. Abbiamo circa sei anni e mezzo di differenza».
Quale rapporto avevate quando eravate bambini e come si è evoluto nel tempo?
«Nonostante la differenza di età e di sesso, da piccoli io e Mariano ci comportavamo come qualsiasi fratello o sorella, ci volevamo molto bene e giocavamo insieme alternando i giochi femminili a quelli maschili. Ciò non toglie che, proprio come altri fratelli e sorelle normali, a volte litigassimo per delle sciocchezze e spesso fossimo molto gelosi l’uno dell’altro nella conquista dell’affetto genitoriale, reclamato dall’uno per la minore età e dall’altra per la disabilità.
Quando la conoscenza della mia diversità è affiorata in Mariano, verso i sette anni, ossia quando mio fratello ha imparato a conoscere i miei limiti e le mie possibilità, è mutato un po’ il nostro rapporto. Da allora ha cominciato ad aiutarmi nelle piccole difficoltà che incontravo ogni giorno e gioiva con me delle mie vittorie; io lo aiutavo ad affrontare la vita con grinta e con energia, l’aiutavo laddove potevo e lo invogliavo a non demordere nell’affrontare le situazioni avverse».
 Quando ha cominciato a riflettere sul fatto che la sua disabilità potesse influenzare il percorso di crescita di Mariano, nello specifico di crescita adolescenziale?
Quando ha cominciato a riflettere sul fatto che la sua disabilità potesse influenzare il percorso di crescita di Mariano, nello specifico di crescita adolescenziale?
«Mio fratello era nel periodo della piena adolescenza, aveva circa sedici anni, e quando si parlava di disabilità in famiglia, mostrava una certa rabbia nell’esprimere opinioni sulla mia situazione, cosa che precedentemente non era mai emersa, perché si era mostrato sempre molto sereno sull’argomento.
Mi confrontai quindi su questa mia percezione con mia madre, che mi rivelò di avere notato le stesse cose in quel periodo. Da premettere che, fino a quel momento, mio fratello aveva sempre partecipato a tutto ciò che la mia disabilità comportava, mi accompagnava quando frequentavo il centro di riabilitazione per la logopedia o la fisioterapia, quando andavo al corso di nuoto o equitazione, quando andavamo alle giornate comunitarie organizzate per i ragazzi con handicap e le loro famiglie… era con noi senza mostrare altro sentimento che non fosse lo star bene, o, per meglio dire, viveva in maniera naturale quelle situazioni.
Proprio quello era il periodo della mia tesi e ho sfruttato questa situazione per studiare lo stato d’animo di mio fratello, confrontandolo anche con quello di altri fratelli e sorelle sane adolescenti, in tutto centoventi. Volevo capire se tale atteggiamento ed eventuali altri vissuti negativi fossero riscontrabili anche in altri siblings [fratelli e sorelle, appunto, N.d.R.] e soprattutto volevo comprenderne il motivo.
Avevo studiato che durante l’adolescenza i ragazzi incominciano ad istaurare delle amicizie e, inevitabilmente, ciò li porta a confrontarsi con le famiglie degli altri amici, famiglie dove spesso non c’è familiarità con la disabilità. Così, partendo da questo punto, ho cercato di capire se queste esperienze di vita differenti suscitassero nei fratelli e nelle sorelle sani di persone con disabilità sentimenti di rabbia e altri vissuti negativi per la sorte diversa toccata alla propria famiglia: è stato in quei momenti che ho pensato a quanto la mia disabilità avesse influenzato la vita di mio fratello».
Qual è la specificità della fase adolescenziale nell’esperienza del sibling di una persona con disabilità?
«Durante l’adolescenza, nei fratelli delle persone con disabilità c’è una minore spinta verso la differenziazione dal sistema familiare e una minor tensione verso il cambiamento, caratteristiche peculiari di ogni giovane “normale”. Nella fase adolescenziale, il fratello di una persona normodotata tenta di cambiare le regole della famiglia considerate superflue o eccessive e tenta di differenziarsi, mettendo in atto le cosiddette “guerre intergenerazionali”. Avverte il bisogno di esperienze extrafamiliari, così da non assumere come riferimento “onnipotente” e autoritario esclusivamente i genitori, e ha voglia di superare il lutto causato dall’attraversamento di una nuova tappa del ciclo vitale.
Invece, il fratello di una persona con disabilità si sforza di non dar parola a questi impulsi interni, adottando un coinvolgimento emotivo minore, quasi a prendere una distanza affettiva e a non gravare sulle difficoltà familiari. Questo meccanismo di “fuga dall’ambiente familiare” – per cui non vi è il consueto scontro generazionale – è una strategia difensiva che il giovane mette in atto per distanziarsi dal problema familiare, rassegnato dal fatto che tanto la situazione non cambierà mai. E tutto ciò lo rende un adolescente “diverso” dagli altri».
Nel libro parla di “asimmetria di ruolo” e “role crossover” (letteralmente “scambio di ruolo”): puo spiegare meglio in che cosa consiste il concetto di “relazione impari”?
«Una relazione istaurata con il proprio fratello disabile sarà di fatto una “relazione impari” perché, inevitabilmente, una limitazione motoria, cognitiva o relazionale condiziona il modo di stare insieme.
In una relazione con un fratello “normale”, entrambe le persone coinvolte mettono in gioco se stesse spontaneamente; al contrario, in una relazione fraterna in cui uno dei due fratelli è disabile, il sibling sano deve adattarsi alla disabilità. Quando i sibling sani sono più grandi di età rispetto al fratello con disabilità, hanno con lui una relazione asimmetrica, mantenendo un ruolo dominante e iperprotettivo. Questo perché le funzioni tipiche della relazione parentale di accudimento e attaccamento vengono delegate dai genitori al figlio maggiore nei confronti del minore.
Quando invece i sibling sani sono più piccoli rispetto al fratello disabile, avviene quello che Farber chiama il role crossover e cioè uno scambio di ruoli: il fratello minore sano eguaglia e sorpassa le competenze cognitive del fratello maggiore disabile.
Inoltre, i sibling sani spesso sono eccessivamente responsabilizzati nei confronti del fratello con disabilità, cui dedicano molto tempo rischiando di perdere l’opportunità di instaurare relazioni con altri coetanei. Questa privazione comporta sentimenti di isolamento e solitudine e, inoltre, può interferire con la possibilità di intrecciare relazioni con persone dell’altro sesso.
Un altro rischio, infine, dell’eccessiva responsabilizzazione è la maturazione precoce del fratello normodotato, che potrebbe allora percepire i coetanei come “vuoti e superficiali”, “diversi da lui”, sperimentando un sentimento di esclusione».
 Ritiene che il confronto con un fratello con disabilità possa dare anche un valore aggiunto alla formazione personale di un individuo?
Ritiene che il confronto con un fratello con disabilità possa dare anche un valore aggiunto alla formazione personale di un individuo?
«Avere un fratello con disabilità di certo può dare un valore aggiunto alla formazione personale di un individuo. I fratelli e le sorelle di persone disabili sono molto aperti nei confronti degli altri e sviluppano maggiormente la capacità di mettersi nei panni altrui, come conseguenza del fatto che talvolta devono dare parola ad emozioni, gesti e atteggiamenti dei fratelli limitati nei normali canali versali. Si adattano facilmente alle situazioni nuove, grazie anche alla testimonianza del fratello disabile che supera difficoltà a volte contro ogni aspettativa realistica. Inoltre, sviluppano la capacità di aiutare gli altri, dando consigli e conforto.
Rispetto ai coetanei, infine, comprendono prima i compiti scolastici e fanno prima le faccende domestiche, perché hanno imparato da subito a cavarsela da soli, visto che talvolta l’impegno dei genitori è rivolto principalmente al figlio con disabilità».
Quale percezione sociale hanno della disabilità gli adolescenti, rispetto ai quali lei parla di “spaesamento”?
«È vero che oggi, più che in passato, capita di avere in classe un compagno con disabilità, oppure di incontrare per strada una persona con disabilità, perché le famiglie con un componente disabile non hanno più vergogna a condurre una vita normale. Ancora, capita di relazionarsi con impiegati disabili grazie alle politiche sociali di inserimento lavorativo. Ma, secondo me, le persone – e più che mai gli adolescenti – si sono adattati a tali cambiamenti senza ricevere alcuna educazione alla disabilità.
Ci sono alcuni progetti specifici nelle scuole, messi in atto per “buon cuore” di alcuni insegnanti, per altro spesso costretti dalla presenza di un ragazzino disabile in classe. Ma, in generale, gli adolescenti non hanno gli strumenti culturali per affrontare questo tema, per cui non sanno riconoscere i limiti o le potenzialità di una persona con disabilità e, banalmente, non sanno relazionarsi con lei quando la incontrano».
Cosa significa per un gruppo di adolescenti accogliere il fratello o la sorella di una persona con disabilità? Gli eventuali suoi disagi dipendono solo dal suo vissuto personale o anche dall’atteggiamento del gruppo nei suoi confronti?
«Per gli adolescenti, accogliere nel gruppo il fratello o la sorella di una persona con disabilità dovrebbe significare prima di tutto provare una grande empatia nei suoi confronti (partecipare cioè ai suoi sentimenti e alle sue emozioni, mettersi nei suoi panni, aiutando la persona in situazioni molto diverse dalle proprie e quindi non sempre comprensibili). Spesso però i ragazzi non ci riescono o, peggio, cercano di sfuggire a tutto questo. Per questo, il più delle volte, i sibling di persone con disabilità non parlano con gli altri amici del gruppo del proprio fratello o sorella disabile.
Gli eventuali disagi che il fratello sano potrebbe vivere in gruppo penso che dipendano in primis dal suo vissuto, ma con questo non escludo che possano anche trarre origine dall’atteggiamento degli altri nei suoi confronti: entrambi i fattori concorrono. Chi non è direttamente in contatto con la disabilità non può comprendere appieno alcuni vissuti e sentimenti che prova il fratello di una persona disabile. Così, non potendolo comprendere appieno e partecipare alla sua vita, rischia di creargli dei disagi emotivi».
Cos’è un gruppo terapeutico omogeneo?
«Con il termine “gruppo omogeneo” mi riferisco a un tipo di analisi terapeutica di gruppo che offre un sostegno socio-affettivo, favorendo tra i partecipanti l’intimità, la profondità, la confusione, la concretezza: tutte variabili legittimate dall’appartenenza a uno spazio comune, ma soprattutto dalla presenza di un elemento condiviso polarizzante. Nel caso di un gruppo frequentato da sibling, tale elemento è duplice: la vicinanza di età (fascia adolescenziale) e l’esperienza di fratellanza o sorellanza con una persona con una particolare tipologia di disabilità».
In questi gruppi, scrive, «si condivide la sofferenza». Che importanza ha questo passaggio?
«Partecipare emotivamente alle esperienze altrui e riconoscere che i problemi degli altri sono simili ai propri favorisce il superamento dei sentimenti che ho sopra descritto, di solitudine, esclusione e isolamento».
Ha già organizzato un’esperienza concreta?
«Si. Ho dato vita ad un gruppo omogeneo di sibling all’ANFFAS di Treviso. Ormai è un anno che i ragazzi si incontrano e il gruppo va molto bene. I ragazzi si cercano e si incontrano anche fuori. Si aiutano nelle piccole e grandi difficoltà che la disabilità del proprio sibling comporta, ma non solo… è nata tra di loro una bella amicizia che va anche oltre l’avere un fratello disabile. Ora sta partendo un altro gruppo all’ANFFAS di Lanciano (Chieti), ma è ancora agli inizi».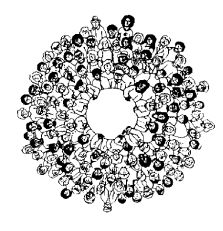
Quali sono le caratteristiche che dovrebbe avere il terapeuta che segue il gruppo?
«Nel gruppo omogeneo il terapeuta dev’essere solo un facilitatore dei processi gruppali e per questo ha bisogno di una formazione clinica. Se è una persona con disabilità, riesce ad entrare meglio nei panni dei ragazzi e a capire come aiutarli, ma la disabilità non è una condizione necessaria. L’importante è che il terapeuta conosca bene il mondo della famiglia in cui c’è un componente con disabilità e che abbia un’età più adulta rispetto al gruppo di adolescenti. Se l’età del terapeuta non è molto maggiore rispetto a quella degli adolescenti, non metterà a rischio la profondità degli scambi all’interno del gruppo».
È possibile un gruppo senza facilitatore?
«Lo immagino solo alla fine di un percorso, quando i membri hanno elaborato i vissuti negativi e si è instaurato tra loro un legame stretto, per cui riescono ad autogestirsi. Quando il gruppo riesce a proseguire da solo, vuol dire che i componenti si frequentano senza dipendenza, anche perché stanno bene insieme. Il gruppo allora diventa un posto di incontro e di mutuo-aiuto».
Ma cos’è esattamente un gruppo di mutuo-aiuto?
«Un gruppo informale, senza regole particolari o procedure stabilite. È una valvola di sfogo, dove poter parlare, piangere, confidare quello che non si può dire o quello che non può essere ascoltato entro le mura domestiche senza scatenare reazioni a catena incontrollabili. Partecipare equivale a ricevere finalmente il “permesso di essere se stessi”. Non c’è nemmeno il terapeuta che invita all’analisi, c’è solo il piacere di esser ascoltati».
Il libro è la pubblicazione della sua tesi di laurea in psicologia: com’è stata l’esperienza accademica?
«Devo ringraziare il mio docente, Paolo Cruciani, di Teorie e Tecniche delle Dinamiche di Gruppo del corso di Psicologia Clinica dell’Università La Sapienza di Roma, che ha creduto nella mia teoria, ossia che i fratelli hanno dei disagi e che un gruppo può aiutarli. Purtroppo, però, dal professore mi sono state date solo poche linee guida per la ricerca del materiale, perché in realtà in Italia c’è poco o niente sull’argomento dei gruppi con fratelli. Per fortuna, mi hanno guidato la mia curiosità su tali tematiche e la conoscenza delle lingue, che mi hanno consentito di attingere a materiali di altri Paesi.
Per quanto riguarda la parte di elaborazione del test e la standardizzazione dei risultati, ho dovuto richiedere all’esterno a qualcuno competente in materia, perché l’Università mi ha un po’ abbandonata a me stessa su questo aspetto.
A livello accademico, infine, la mia tesi ha suscitato molto interesse: il giorno della discussione ho ricevuto tanti complimenti, domande ed esortazioni a portare avanti la mia idea. Il mio correlatore avrebbe voluto portare avanti con me la ricerca, ma non c’era la possibilità concreta di farlo. Dal canto suo, la mia correlatrice mi ha suggerito allora di presentare la mia tesi ad alcune associazioni del mondo della disabilità, per testare l’interesse che poteva suscitare. Così ho pubblicato il libro e con un’associazione ho realizzato un progetto nelle scuole, lavorando con alcune studentesse sorelle di persone con disabilità».
Di che cosa si occupa ora?
«Da pochi mesi lavoro in un Centro di Formazione Professionale di Milano e sono la responsabile dello Staff Sostegni. Coordino l’operato di due insegnanti di sostegno e facilito l’apprendimento di sedici studenti con diverse tipologie di disabilità, pensando per loro attività e materiali personalizzati per il raggiungimento degli obiettivi scolastici e professionali a seconda dell’indirizzo di corso (Oreficeria e Servizi all’Impresa)».(Barbara Pianca)
*Autrice del libro Siblings adolescenti di persone diversamente abili: proposta di gruppo omogeneo, Napoli, ESI (Edizioni Scientifiche Italiane), 2009.
Articoli Correlati
- Tra fratelli e sorelle ci si aiuta Essere fratelli o sorelle di persone con disabilità - definiti "all'inglese" siblings - è un’esperienza particolare: a Treviso la psicologa Valeria Coppola ha dato vita a un gruppo in cui…
- La Linea Guida sull'autismo come esempio per parlare di valutazione dell'efficacia Come preannunciato nei giorni scorsi, dopo essersi soffermata sulle caratteristiche della "Linea Guida" sull'autismo, recentemente prodotta dall'Istituto Superiore di Sanità, Maria Luisa Gargiulo dedica ora un ampio approfondimento alla valutazione…
- Dopo di noi da creare “durante noi“* L'organizzazione del futuro di una persona con disabilità: quali sono le tutele giuridiche esistenti? In quali ambienti si potrà svolgere la vita di quella persona? E con quali fondi? Un…

