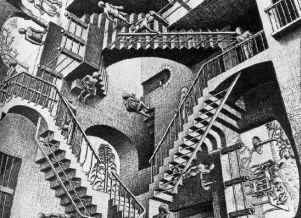
Uno dei fenomeni più controversi, nella storia recente del welfare, è sicuramente quello legato alla proliferazione di piccole, e a volte piccolissime, associazioni di familiari, i cui componenti, almeno per quanto riguarda l’autismo, hanno (spesso) in comune la caratteristica di provenire dalla stessa “casa madre”. Molte ne rivendicano piena autonomia, persino ai tavoli istituzionali, minando così – alle fondamenta – il concetto stesso di associazione “maggiormente rappresentativa”.
A tale proposito è il caso di ricordare che le condizioni per definire rappresentativa un’associazione di difesa degli interessi (advocacy), sulla base della Legge 438/98, sono: indipendenza (da conflitti di interesse); inclusività (nel caso specifico dell’autismo “rappresentatività di tutte le persone con disturbi dello spettro autistico”); democrazia (democraticità dello statuto, elettività delle cariche); diffusione sul territorio nazionale in almeno 10 Regioni.
Sotto il profilo giuridico mi limito qui a sottolineare che esaminando anche la Legge 476/87 (articolo 2, comma 1, lettere a e b), potrebbero essere sollevati forti dubbi interpretativi, in particolare per quanto attiene al requisito della presenza in un certo numero di Regioni, a conferma che l’ambiguità del contesto legislativo è tutt’altro che estranea alla confusione imperante in materia.
Personalmente non credo affatto che la rappresentatività si misuri (solo) con meri criteri burocratici. Fatta questa affermazione, mi chiedo però se esista un collegamento, e quale, tra la crisi di partecipazione, di cui soffrono oggi le associazioni maggiori, e il moltiplicarsi sul territorio di nuove esperienze associative.
Se così fosse, inevitabilmente, si porrebbero alcune domande: che giudizio dare di questa perdurante frammentazione? Da cosa ha origine? È possibile contrastarla? Attraverso quali strumenti? Per fare cosa?
Ho l’impressione che i nodi appena richiamati debbano essere sciolti in fretta, qualunque sia l’associazione di riferimento. Siamo davanti solo a “schegge impazzite”? A iniziative personalistiche? A obiettivi velleitari? O quella in corso è una vera e propria crisi di rappresentanza?
Certo è che un fenomeno così complesso non può essere banalizzato. Impossibile liquidarlo assumendo l’atteggiamento snobistico di alcuni, senza sforzarsi di capire cosa ci sia alla base di un distacco crescente che ci interroga tutti, anche a fronte di situazioni in cui i genitori si allontanano, scegliendo di richiudersi in una dimensione tutta privata: il segno di una sconfitta altrettanto grave.
Credo che in molti casi la disaffezione sia figlia non solo di obiettivi e piattaforme strategiche per lo meno rivedibili, ma anche (e chissà se soprattutto) di uno scarso dibattito interno, di un modo di decidere talvolta aristocratico ed elitario, in una parola di una concezione degli iscritti che li associa sempre più spesso a meri destinatari di scelte prese altrove (lo so: non mancano, né mancheranno, lodevoli eccezioni, ma queste non possono essere assunte a pretesto per assolvere tutti o, peggio ancora, autoassolversi).
Un dato paradossale è che certe caratteristiche non sono affatto patrimonio di una sola associazione. Non di rado, infatti, càpita di trovarsi davanti a una sorta di “eruzione di rancori” o a un virus pervaso di mediocre provincialismo, che producono e alimentano un settarismo viscerale… laddove è del tutto evidente che il solo pensare che un’idea possa essere condivisa «purché coincida con la mia» o la critica sia giusta «purché non mi tocchi», non può che produrre fibrillazioni, diffidenze e veti incrociati che non sono di alcuna utilità, perché – diciamocelo – se questo è l’approccio, diventa poi complicato… rimettere il dentifricio, che nel frattempo è fuoruscito, all’interno del tubetto.
Per tale elementare ragione va riaffermato, una volta per tutte, il principio che le scelte richiedono, prima di essere portate a sintesi, la partecipazione, la condivisione e il contributo di tutti, con la sola discriminante che tutti devono – dobbiamo – assumere a riferimento la Linea Guida n. 21 dell’Istituto Superiore di Sanità, sui trattamenti dell’autismo e tutti le raccomandazioni della comunità scientifica internazionale.
La rappresentatività, a mio parere, non è una variabile indipendente, ma è legata a un processo in fieri che prevede la verifica di un insieme di fattori di cui quello dimensionale, per quanto importante, non spiega sicuramente tutto. L’esperienza dimostra infatti che piccole associazioni possono a volte conseguire eccellenti risultati, che organizzazioni storicamente ben più strutturate, e all’apparenza – ahimè, solo all’apparenza – radicate sul territorio, non si sognano nemmeno!
Chissà che non sia tempo, allora, di sforzarsi di individuare tre o quattro criteri che aiutino a definire la rappresentatività anche con il buonsenso (parola forse desueta, ma assolutamente da “rivalutare”).
In questo senso la mia idea è che si sia rappresentativi se si diventa portatori di un progetto strategico intorno al quale si registra un ampio consenso; se si è coerenti con il mandato ricevuto dalle famiglie; se non si cercano a tutti i costi scorciatoie e mediazioni improponibili; se davanti a palesi negligenze e inadempienze della politica si reagisce con fermezza, mettendo in campo iniziative di protesta e mobilitazione, anziché retorici e logori appelli alla comprensione. Si è rappresentativi se si sostengono “concretamente” i diritti dei nostri figli, senza pietire – verso sindaci, consiglieri, assessori, sottosegretari, ministri, direttori di ASL, responsabili di Servizi Sociali, portaborse, commessi, funzionari, e chi più ne ha più ne metta – ciò che invece è dovuto.
Trovo che in un contesto come l’autismo suggestioni del tipo “il fine giustifica i mezzi” (detto in altro modo: “mi alleo con chiunque pur di raggiungere il mio scopo”), siano del tutto inadeguate e lesive della dignità nostra e dei nostri figli.
So che qualcuno pensa che alla base dell’implosione, lenta ma inesorabile, di cui ci stiamo occupando, possa esserci anche un certo mancato ricambio generazionale al vertice di alcune organizzazioni. Francamente non ne sono convinto al cento per cento, anche se non esito a dire che vedrei con favore la presenza di genitori più giovani in ruoli di maggiore responsabilità. Ma più che di una discutibile “rottamazione”, confesso di avvertire, in primis, il bisogno di buone idee e buone prassi (concetti, in tutta evidenza, non associabili – sic et simpliciter – a un criterio anagrafico).
Concludo: la critica, tanto più se muove dalla comune consapevolezza di assumere a riferimento la Linea Guida n. 21 dell’Istituto Superiore di Sanità e le raccomandazioni della comunità scientifica internazionale, può, a mio parere, portare a sbocchi meno radicali del moltiplicarsi frenetico di nuove associazioni.
Invece che la chiusura pregiudiziale, l’autoreferenzialità, la critica sterile, spesso messe in mostra con discutibile nonchalance, è tempo di sperimentare metodi e modelli di lavoro (una federazione?) che, nella prospettiva di un graduale ravvicinamento, consentano – per cominciare – l’attenzione, l’ascolto e il rispetto (non formale) reciproci. Dico questo perché per risolvere un problema la prima cosa da fare… è riconoscere che c’è!
È dunque importante lavorare alla ricerca di ciò che unisce, piuttosto che di ciò che divide, in modo da tornare a parlare, un giorno, con una voce unica e autorevole. L’unità, piaccia o non piaccia, è un bene prezioso, e metterlo a repentaglio per l’esibizione talvolta troppo ostentata del requisito della sola consistenza numerica (da una parte) e del protagonismo fine a se stesso (dall’altra) è un lusso che non possiamo concederci.
Lo sanno bene i nostri interlocutori istituzionali, che non esitano a ricorrere a una tecnica dilatoria ben assortita, sapendo che accontentare un po’ l’una un po’ l’altra associazione paga. Divide et impera, infatti, è una lezione che (loro) hanno imparato benissimo. Probabilmente noi no! O quanto meno non del tutto!
Padre di una persona con autismo trentatreenne, insegnante e scrittore, autore del libro Mio figlio è autistico (Vannini, 2013).
Articoli Correlati
- L'integrazione scolastica oggi "Una scuola, tante disabilità: dall'inserimento all'integrazione scolastica degli alunni con disabilità". Questo il titolo dell'approfondita analisi prodotta da Filippo Furioso - docente e giudice onorario del Tribunale dei Minorenni piemontese…
- Servizi socio-assistenziali e costi per gli utenti Un parere del Difensore Civico della Regione Marche, in tema di contribuzione al costo dei servizi socio-assistenziali da parte degli utenti, sembra parlare chiaro: «L’utente può essere chiamato a contribuire…
- L’autismo e le vaccinazioni «L'evidenza scientifica smentisce l’esistenza di una relazione causale tra vaccino MMR e disturbi dello spettro autistico» e «Una parte consistente dell'evidenza epidemiologica non dimostra alcuna associazione tra vaccino MMR e…

