
Vicenza, Sanremo, Nocera, Treviso, Grottaferrata, Agrigento, Cagliari, Roma, Parma, Vercelli… Da nord a sud, in montagna e in città, senza dimenticare le isole, gli episodi di violenza, di abuso, di intolleranza commessi da insegnanti, educatori, operatori verso persone deboli loro affidate sono presenti nelle cronache. Se ciò dipenda da maggiore attenzione dei media o se sia un fenomeno in aumento non lo so dire, anche se ho la sensazione che la seconda ipotesi non sia priva di fondamento. Ma anche se fosse solo un episodio, sarebbe già troppo, soprattutto se noi, la comunità degli educatori, dei formatori, degli operatori in relazione di aiuto non saremo capaci di affrontare con urgenza e determinazione l’argomento: parlandone prima di tutto e non tacendo in modo assordante.
Qual è l’argomento? Provo a cercare la parola giusta e mi accorgo di scrivere decine di parole e poi di cancellarle ogni volta, perché una non basta oppure non è quella giusta. Sono tante parole, non tantissime, ma devono essere saldate l’una all’altra in un nuovo neologismo: ci metterei dentro rispetto, poi legalità. Poi le altre.
Troppo grande il baratro che si è creato tra chi sostiene che per occuparsi del sociale e dei deboli basti solo tanto amore, così facile da dichiarare e da credere, tra brochure patinate che descrivono le meraviglie di luoghi per accogliere persone con problemi, e quel che a volte ci sta dietro. Non succede all’inizio, quasi mai, ma dopo, e quando comincia? si accumulano situazioni e si va incontro al lato oscuro.
Penso al documentario 87 ore di Costanza Quattriglio, che racconta la morte in diretta di Francesco Mastrogiovanni dopo un TSO [Trattamento Sanitario Obbligatorio, N.d.R.]. Penso agli avvocati che in prima istanza hanno fatto assolvere gli infermieri perché «stavano ubbidendo alle disposizioni del medico». Ma in appello qualcuno sta dicendo che no, non può essere così, la banalità del male (Hannah Arendt, 1963) non può essere il principio evocato ogni volta che prevale il voltare la testa altrove. Ci vuole coraggio per affrontare le criticità, ma questo coraggio è il primo elemento, direi un pre-requisito, per essere uomini e donne, e non dei quaquaraquà.
Una delle cose che più mi da fastidio, profondo fastidio, è la corsa frettolosa dopo ogni episodio a trovare la “persona-melamarcia”. Le Istituzioni che sponsorizzano le gare al massimo ribasso per gestire i servizi, poi sono le prime a costituirsi in giudizio. Ma non dovrebbero essere chiamate a rispondere? È tranquillizzante pensare che basti periodicamente buttare via il “frutto bacato”, dire grazie ai Carabinieri che piazzano le telecamere. Dare un abbraccio solidale ai parenti. Ma se i Carabinieri devono raccogliere le prove, servono giorni, settimane, mesi. E nel frattempo noi (quelli che in questi luoghi ci lavorano) che facciamo? Noi non dobbiamo trovare le prove, noi dobbiamo arrivare prima e comprendere quel che accade, per impedire che possa ripetersi. Oppure allarghiamo le équipe, inserendo un militare in incognito?
Perché, perché tacciono gli educatori, gli insegnanti, gli operatori?
Quanta gente, quanti operatori, quanti servizi, pensano che non sia problema loro, che da loro non succederà mai? Quanta consapevolezza c’è di cosa sia un abuso, una violenza, una intolleranza? Quante sono le forme di violenza strisciante che non arrivano alle cronache, ma segnano comunque la vita di persone, e come si arriva lì, come prevenire che marcisca una buona mela, come evitare di assumere fin dall’inizio chi non ha le competenze per lavorare nella relazione di aiuto? Come coniugare il diritto al lavoro con il diritto ad avere qualità di vita? E quante domande si aprono ancora?
Ho letto in questi giorni qualche “esercizio lombrosiano” per cercare di costruire il profilo dell’operatore-abusatore. Non giovane, con tanti anni di servizio, forse prossimo alla pensione. Ma non si indignano le migliaia di bravi operatori che da trent’anni tirano la carretta davanti a simili giudizi, costruiti forse da chi non è mai stato a contatto con la fatica e il limite? I tagli alla formazione e all’aggiornamento sono altro rispetto a simili episodi?
Mi scuso per citare me stesso, ma continuo a pensare cose che ho già scritto, quindi faccio copia e incolla per economia; quando scrivevo queste riflessioni, mi ponevo l’obiettivo di dare un contributo a un dibattito che tarda ad aprirsi [d’ora in poi gli spunti virgolettati sono tratti da Mario Paolini, “Disabilità e qualità dell’incontro. Relazioni interpersonali nell’educazione e nella cura, Milano, FrancoAngeli, 2015, N.d.R.].
«Fa male sentirsi soli, si corre il rischio di abituarsi e di pensare che sia giusto così, che ciascuno debba arrangiarsi. A volte non è semplice provare a capirsi quando le cose non vanno, quando una relazione è ostile; sembra un destino piuttosto che un problema da affrontare e risolvere, invece quando le cose vanno bene si sottovaluta l’importanza delle buone relazioni, più attenti al bicchiere mezzo vuoto che a quel che già c’è. La qualità della relazione è un concetto difficile da visualizzare, ciò che si costruisce è impalpabile e permeabile ma come per l’aria la qualità si avverte e si cerca. Servono strumenti e strategie per averne cura e queste due parole me ne fanno venire in mente una terza: sostegno».
«Che peso dare al normale logoramento, naturale e prevedibile che interviene con il tempo in tutti i meccanismi? Che peso hanno nel lavoro sociale di rete le fatiche aggiuntive prodotte da cattive dinamiche relazionali tra persone chiamate a lavorare insieme in un servizio e tra servizi in rete?».
Scrivevo queste parole riflettendo sulla necessità di manutenzione dell’esistente, dei muri e delle persone; della necessità di garantire la cura della cura. Il paragrafo successivo, invece, è proprio relativo al tema degli abusi e delle violenze. Lo ripropongo integralmente qui di seguito, perché mi sembra attuale.

«Il fumo di Hadamar. È un tema difficile quello degli abusi. Quando si cerca di dare rilievo alle cose che funzionano e si propone una visione comunque pro-positiva si rischia di apparire astratti, buonisti, lontani dalla realtà di episodi che si vedono quotidianamente in molti, troppi, servizi. Quanti sono i fatti di violenza tollerati e messi a tacere ogni giorno? Per un episodio che raggiunge le cronache dei giornali o della televisione, quanti ce ne sono che rimangono coperti? Chi sono le persone che vanno oltre i limiti? Come si diventa così? Una impressionante foto d’epoca riprende il fumo che esce dal camino del castello di Hadamar, (fu uno dei principali centri di sterminio di persone disabili e malate di mente dal 1939 al ’41, dove furono “collaudati” i forni crematori poi utilizzati nei campi. Una foto scattata da un abitante della cittadina ai piedi del castello evidenzia come il fumo dei forni era evidentissimo a tutti, assieme al puzzo insopportabile, eppure tutti tacquero. fumo nero di corpi bruciati di cui posso immaginare l’odore, fumo che tutti vedevano perché il castello era in mezzo alle case e gli abitanti non potevano non vedere). Non è tanto il fumo in sé a preoccuparmi quanto il fumo in me, la parte cattiva che vedo in altri ma che so abitare anche in me.
L’esperimento Milgram del 1961 [che documentò come persone assolutamente normali possono, in determinate condizioni di delega della propria condotta, spingersi oltre ogni ragionevole limite e commettere delle violenze che nessuno sarebbe disposto ad ammettere in circostanze usuali, N.d.A.] fornì oltre cinquant’anni fa alcune agghiaccianti spiegazioni possibili al fatto che le cose cattive non sono fatte solo dai “cattivi” ma che ogni brava persona può in determinate circostanze comportarsi in modo ignobile. Forse vi sono altre spiegazioni più semplici da accettare: esiste il mostro come esiste la viltà, forse a qualcuno piace avere delle vittime a cui imporre le proprie miserie, forse in qualche caso ci vuole davvero un grande coraggio a ribellarsi: è facile dire che bisogna ribellarsi alla camorra se si abita in una tranquilla cittadina del Nord, ma se fossi nato a Scampìa? È facile dire che i vecchi non si devono legare al letto, ma se l’ho sempre visto fare fin dal mio primo giorno di lavoro? E se lo vedo fare e sto zitto o faccio finta di non avere visto perché ho paura di perdere il posto di lavoro se parlo o forse, semplicemente, perché penso che non sono cose che mi riguardano? Quanto tempo ci metto ad abituarmi a quel fumo? Come la mettiamo con la gente che prima dice e pensa “che bravi quelli che lavorano con gli handicappati o con i matti” e poi vede che non è proprio sempre così? Santi o bastardi?
I servizi diurni e residenziali che oggi vediamo non hanno una storia antica, sono aperti da una trentina di anni o poco più. È circa la stessa età degli SPDC [Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura, N.d.R.], i servizi che hanno sostituito i manicomi dopo la Legge 180 di Franco Basaglia. Prima c’erano gli istituti e chi ci lavorava dentro non sempre aveva preparazione, era già tanto che li “tenessero”. Pinel nell ’800 sciolse i matti tenuti in catene legate al collo come i cani, ma troppe volte sono state sostituite dalle cinghie di contenzione, dall’onnipotente farmacologia. I servizi che accoglievano i “ragazzi” disabili trent’anni fa erano orientati a dare spazio ai casi meno gravi, perché gli altri per molto tempo ancora restarono nascosti in casa o in istituto.
Quanti servizi oggi scoppiano perché incapaci di gestire i casi gravi, (incapaci?) di applicare i principi dell’integrazione e dell’inclusione nelle situazioni difficili? Quanti genitori di bambini con disturbi del comportamento si sentono rifiutati dalla scuola e cosa pensano quei bambini? Quant’è sottile il confine tra diventare tante piccole parti di un “manicomio diffuso”, dépendaces in rete ma di un istituto, o essere qualcuno (qualcosa) che giorno dopo giorno prova per davvero a costruire futuro, senza eroismo ma con tenace civismo? Perché questo confine venga attraversato, senza rendersene conto, non servono oscure organizzazioni: basta sottovalutare le stanchezze, un po’ di mediocrità in più, far prevalere un pensiero assistenzialista; alle volte è per distrazione, brave persone oberate da mille incarichi.
La cultura dell’integrazione non merita di cedere alla mediocrità e all’affanno, le tante brave persone che ogni giorno ci provano a lavorare bene meritano di sentirsi dire brave, di percepire l’appartenenza a un insieme capace di valorizzare e sostenere chi ne fa parte. È un desiderio legittimo di chi è direttamente coinvolto ma è anche un bisogno di tutti per contrastare altre derive: dare voce e saper ascoltare queste voci è una necessità non rinviabile. La discussione in psichiatria tra chi ritiene giusto applicare la contenzione e chi no è meno vivace di quanto ci si potrebbe aspettare in un paese che ha rivoluzionato l’idea stessa di psichiatria; mi chiedo quale sia il livello analogo di discussione nelle case di riposo e nelle strutture dove ci sono persone con disturbi del comportamento.
Si sta troppo in silenzio di fronte alla ripresa di un modello di separazione anziché di inclusione, all’aumento di voci a sostegno di azioni escludenti “fatte per il bene della persona” si dice. Diminuisce il tempo in cui ci si sofferma ad ascoltare il disagio, si cerca di incontrare l’altro, si riflette su di sé nella relazione con l’altro. La crisi economica gioca a sfavore, perché se i fondi a disposizione di una piccola cooperativa o di una associazione che gestiscono un servizio diminuiscono e si è obbligati a fare la formazione sulla sicurezza altrimenti saltano i parametri e salta l’appalto, non ci sono le risorse per altre importanti manutenzioni sul capitale umano e il risparmio paga di più dell’investimento, lo si vede nei tagli alla ricerca e lo si vede in questi ambiti meno noti.

Segnali di guerra che stridono con la cultura e la conoscenza, alimentati da intolleranza che forse è figlia di un clima avvelenato prima da altri fattori, trascurati e sottovalutati, come la precarizzazione, come la perdita di riferimenti, la drammatica perduta voglia di partecipare. A volte penso che la maggiore e più urgente priorità, per la scuola e per il mondo sociale se vuole sopravvivere, sia di intervenire sull’ambiente. Dobbiamo assolutamente recuperare la gente, quelle persone che non conoscono nulla del nostro lavoro, che non hanno idea e nemmeno l’intenzione di farsene una; abbiamo bisogno di quelle persone almeno quanto esse hanno bisogno di noi: fare i conti con questo scenario non comporta il cambiare idea ma solo ridefinire cosa si può fare con un approccio pro-positivo che sa godere dei piccoli passi. Non è facile però c’è chi lo sta facendo con buoni risultati. Per quanto mi sia faticoso anche solo dirlo, devo essere solidale anche con l’operatore aguzzino che ha messo le mani addosso ai vecchi in una casa di riposo in Liguria: perché ho bisogno di capire come si arriva ad essere così, a essere diventati come lui. Devo cercare di capire anche come stavano gli altri che erano lì: che hanno visto e hanno taciuto. Devo essere solidale con l’insegnante e l’operatrice che hanno picchiato più volte un ragazzo autistico in una scuola del Veneto perché solo ascoltando anche le loro voci posso sperare di capire. Essere solidale non vuol dire essere complice o schierato dalla loro parte, non vuol dire neppure essere neutrale. Ma non posso essere solo accusatore o giudice che condanna, devo impedire che si ripeta, capire per prevenire.
Massimiliano Verga è un professore universitario padre di tre figli,uno dei quali gravemente disabile. Zigulì La mia vita dolceamara link è un libro duro da leggere e commovente come un paesaggio di montagna: si sente il bisogno di restare un po’ silenzio davanti a entrambi. In uno capitolo Verga scrive parole crude: “anche dei chiodi nelle mutande sono più piacevoli della tua voce. Quando urli così non ho scelta. O ti sbatto in camera e chiudo la porta, oppure ti prendo a sberle. Quasi sempre finisci in camera. La ritengo una conquista” (p. 55).
Un giorno stavo discutendo con dei genitori di bambini disabili in una scuola e avevo citato questo passo; una mamma, bellissima e senza sorriso, mi disse guardandomi fissa “ma guardi che è proprio così!” Con semplicità quella donna mi svelava che i genitori lo conoscono bene il confine oltre il quale abita la violenza. Si comincia perdendo le staffe perché la situazione ti porta fuori di testa e tutte le belle parole dette da altri non contano un maledetto fico secco. Quel giorno ho capito che i genitori hanno sempre diffidenza delle persone a cui affidano i propri figli perché sanno a che fatiche andranno incontro e che a quelle fatiche è già capitato anche a loro di non saper far fronte. Hanno paura, e non hanno bisogno di essere rassicurati, sono obbligati a fidarsi per poter af-fidarci il loro figlio e poter avere qualche attimo per sé.
Non la faccio facile, sono seduto in poltrona mentre sto scrivendo, ma penso cosa farei se fossi un genitore a cui hanno detto che la maestra o l’educatore picchiava il figlio: se me li lasciassero per due minuti? Ma questo pensiero da Far West non è forse quello che contribuisce a mantenere intatto il problema? Non è proprio il modello dell’esclusione, quello per cui siamo noi a non voler vedere e sapere cosa si fa di quelle persone che non sono adatte a stare insieme con gli altri e a pretendere che qualcuno se ne occupi. E poi ci scandalizziamo se alzano le mani? Lo scandalo è eludere il problema, e tagliare le risorse abbattendo le ore di formazione e di supervisione, inutili e improduttive. Di solito chi decide questi tagli non è mai stato dentro una di quelle situazioni: se ne dovrebbe parlare.
Non la faccio facile, so abbastanza bene quanto è semplice dire e anche sapere quali sono le cose giuste da fare quando non si è coinvolti, ma quanto invece cambia tutto se ci sei dentro. Chi ha a che fare con una delle 500.000 persone malate di Alzheimer che si stima oggi siano colpite dalla malattia in Italia sa che non è facile. Saprei cosa dire alla badante che vive in casa con la persona ammalata, saprei accorgermi di qualcosa che non va e qualche volta potrei indignarmi nel vedere qualcosa da non vedere: ma so in quanto poco tempo si perde la pazienza con casi del genere senza la dovuta preparazione e senza una adeguata rete di sostegno? È un caso che il turnover tra queste figure sia molto alto? Sono solo loro inadeguate? Mi scrive un amico: “quando arrivò, lei (la badante ucraina) mi diceva: ‘ma si, porta pazienza, è la malattia; riusciva a vedere le cose in modo meno negativo rispetto a me. Io ero bruciato, lei era fresca. Dopo un mese io mi ero rimesso un po’ in sesto, lei stava iniziando a bruciarsi’. Unico rimedio possibile: eliminare il problema? Il pensiero viene, non poche volte”. Soprattutto quando vince la rabbia dell’impotenza, quando l’agire di pancia vince sulla riflessione, sul distanziarsi. Invece, se si riesce a diminuire il bisogno di dover fare qualcosa, a dare un posto alla rabbia del sentirsi impotente e impossibilitato a uscire da una situazione da cui si vorrebbe scappare via, si dà un po’ di aria al patire, al sentire pathos. E c’è posto per tutti i sentimenti che hanno a che fare con il patire, compresa l’antipatia: ma non l’a-patia, perché è quella che fa male, mentre le altre forme del patire stanno dentro qualcosa che si chiama vivere.
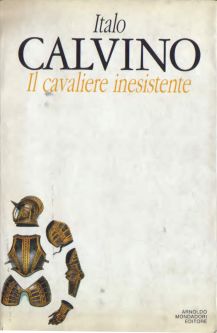
Penso alle scene che ho visto in un video girato dalle forze dell’ordine di operatori, donne e uomini, che malmenavano dei vecchi con l’Alzheimer in una casa di riposo. Non era un film. E se domani toccasse a me? cosa? Di perdere il controllo o di essere malmenato? In entrambi i casi meglio pensarci prima e provare a continuare a costruire qualcosa di meglio: perché è possibile, perché c’è un sacco di gente e di posti dove si lavora bene. Ci sono SPDC dove non si lega la gente e le porte sono aperte; ci sono medici in nuclei Alzheimer che provano a far star bene quelle persone, riducono i farmaci, discutono con gli operatori e ascoltano le loro stanchezze; ci sono insegnanti che le prendono qualche volta dai loro alunni pazzerelli, ma che non si sognano di fare altrettanto o di mandarli in qualche altrove. Non credo che costi di più lavorare così, ma se anche fosse è quel si deve fare, da quando nella scuola si è cominciato a parlare di integrazione, da quando nel 1978 nel nostro paese è passata la riforma della sanità, diventata diritto per tutti e non privilegio di pochi.
Tre uomini dal sud del mondo hanno detto parole che mi aiutano a trovare senso a ciò che penso e provo a dire: Ernesto Che Guevara ha detto che “bisogna essere duri ma senza mai perdere la tenerezza”. Nelson Mandela ha detto che “il coraggio non è l’assenza della paura ma il trionfo su di essa”. Papa Francesco ha detto che “non bisogna avere paura della tenerezza”. Uomini profondamente diversi ma i tre pensieri sono quasi consequenziali l’uno all’altro. La necessità di esser duri con tenerezza la conosce bene chi lavora con certi casi difficili perché è il giusto mix di atteggiamenti per essere autorevoli e non autoritari, il coraggio di restare quando si ha paura lo hanno sperimentato in tanti e non è facile, ma il non aver paura della tenerezza è davvero una grande intuizione e ci aiuta a riflettere che non c’è proprio nulla di scontato nelle emozioni in gioco nei rapporti interpersonali, specialmente dentro le relazioni di aiuto, quella cosa che Italo Calvino fa scoprire al suo Cavaliere Inesistente alla fine del romanzo – Ci siete, cavaliere, nessuno può più negarlo ormai! – Non gli risponde alcuna voce. L’armatura non sta su, l’elmo rotola in terra. -, avete resistito tanto tempo con la vostra sola forza di volontà, siete riuscito a far sempre tutto come se esisteste: perché arrendervi tutt’a un tratto? – Ma non sa più da che parte rivolgersi: l’armatura è vuota, non vuota come prima, vuota anche di quel qualcosa che era chiamato il cavaliere Agilulfo e che adesso è dissolto come una goccia nel mare (cap. 9)”».
Carlo Giacobini, con la sua consueta tempestività, ha pubblicato nella sua pagina Facebook un articolo [“Basagliani odori di merda e morte”, N.d.R.] sul tema degli abusi emersi in questi giorni e fa bene a porre l’attenzione sulla necessità di vigilanza e corresponsabilità per la classe politica e gli amministratori pubblici. Io qui sto parlando di qualcosa che riguarda noi, gli operatori e che quel qualcosa va fatto senza aspettare oltre e senza che siano altri a chiederlo.
Credo che restare in silenzio equivalga ad una rinuncia alla propria identità e alla propria storia; deve essere data a tutti la possibilità di parlarne senza paura, perché troppe volte mi son sentito dire frasi come questa: «Ma quando vedo una violenza se parlo poi mi fanno fuori, io sono precario, sono appena arrivato, sono…». Tutti devono essere stimolati prima e obbligati poi a parlare, a parlarne: tra di noi e non dal magistrato.
Il popolo tedesco uscito dall’abominio del nazismo è stato capace di scrivere nella propria Costituzione parole che scuotono chiunque le senta, sapendo da dove provengono e conoscendo ciò che accadde prima: «La dignità dell’uomo è intangibile». Queste sono le prime parole della Costituzione del popolo che visse dall’interno il nazismo.
La dignità dell’uomo è intangibile, è così smisurata da non poter essere scalfita da nulla e da nessuno, ed è compito di ciascuno preservarla. Molti fatti quotidiani ci ricordano che uomini e donne deboli, fragili, possono ancora diventare agli occhi di altri Lebensunwertes Leben, “vite indegne di essere vissute”.
Mi manca tanto Franco Bomprezzi, ne avevamo parlato, chissà cosa avrebbe detto. Forse «Wake-Up»! [“Svegliarsi”!, N.d.R.].
Pedagogista e formatore. Il presente testo è già apparso (con il titolo “Violenze nei servizi. Ci riguarda!”) nel sito del Gruppo Solidarietà e viene qui ripreso, con minimi riadattamenti al diverso contenitore, per gentile concessione. In calce riportiamo anche l’introduzione pubblicata in quella sede dallo stesso Gruppo Solidarietà.
Introduzione del Gruppo Solidarietà alle riflessioni di Marco Paolini riprese dal nostro giornale
Quanto vediamo e leggiamo con cadenza quasi giornaliera ci sgomenta e ammutolisce. Ma passato lo sgomento, sappiamo bene che occorre parlarne, riflettere, confrontarsi, senza facili scorciatoie che rischiano di essere autoassolutorie. Si tratta di una questione e di un problema che riguarda tutti. Ci riguarda tutti.
Mario Paolini ne aveva già scritto nel suo ultimo libro “Disabilità e qualità dell’incontro. Relazioni interpersonali nell’educazione e nella cura”, Milano, FrancoAngeli, 2015, N.d.R.] e ne avevamo discusso in un incontro pubblico alla fine del 2012, poco dopo le violenze, documentate dalla Guardia di Finanza, in una struttura per anziani a Sanremo.
Gli abbiamo chiesto di proporci alcune riflessioni a partire dal suo punto di osservazione: operatore e formatore in servizi per persone con disabilità. Lo proponiamo, auspicando che del tema si parli (non facendone una chiacchiera) davvero. Ne parlino gli operatori che lavorano nei servizi, così come si interroghino e riflettono le Istituzioni che “prendono in carico” le persone con il compito di assicurare risposte adeguate ai loro bisogni (si leggano a tal proposito le riflessioni di Carlo Giacobini in Facebook, che facciamo nostre). Il compito troppo spesso appare compiuto con la “collocazione”. Qualsiasi essa sia.
Riflettiamo anche sulla crescente spinta alla “privatizzazione del bisogno”, che porta le persone ad avere sempre più rapporti di tipo privatistico con le “strutture” che erogano servizi.
Una cosa appare comunque certa: il “sistema” non funziona. E se ciò sembra innegabile, occorre mettere in fila tutte, ma proprio tutte, le questioni (autorizzazioni, standard e tipologia di personale, qualifiche professionali, capacità recettive, utenti, obiettivi, criteri di ammissione, verifiche, formazione, controlli, ecc…) e con determinazione affrontarle.
Gruppo Solidarietà
Articoli Correlati
- Il Disegno di Legge Zan e la disabilità: opinioni a confronto Riceviamo un testo dal sito «Progetto Autismo», a firma di Monica Boccardi e Paolo Cilia, che si riferisce, con toni critici, a un contributo da noi pubblicato, contenente due opinioni…
- L'integrazione scolastica oggi "Una scuola, tante disabilità: dall'inserimento all'integrazione scolastica degli alunni con disabilità". Questo il titolo dell'approfondita analisi prodotta da Filippo Furioso - docente e giudice onorario del Tribunale dei Minorenni piemontese…
- Come raccontare la violenza sulle donne con disabilità Qual è il modo più corretto per parlare della violenza nei confronti delle donne con disabilità, persone che spesso soffrono di una discriminazione multipla, legata cioè sia al loro essere…

