
Se avessimo una macchina del tempo, stile Ritorno al futuro, e decidessimo di fare un salto indietro di migliaia di anni, quale sarebbe la condizione di vita delle persone con disabilità che incontreremmo? Libri e articoli sull’evoluzione dell’integrazione sociale si sprecano, ma più andiamo indietro, più ovviamente è difficile reperire informazioni, ci sono poche certezze e si entra nel campo delle ipotesi. Ci vengono incontro reperti della quotidianità, resti umani (un po’ macabri ma preziosissimi per gli studiosi) e per le epoche in cui già l’uomo si esprimeva per iscritto, alcune superstiti fonti scritte.
Quello che si riesce a supporre con ragionevole veridicità è tuttavia sorprendente, a volte in senso negativo e altre in positivo. Ci facciamo accompagnare in questo viaggio a ritroso da quattro persone con disabilità, due famosissime e altre due semisconosciute.
Cominciamo da queste ultime, le più “vecchie”, risalenti al Paleolitico Superiore, periodo compreso tra circa 35.000 e 10.000 anni fa, l’Età della Pietra che vide l’insorgenza di una cultura primitiva, caratterizzata dall’attitudine alla progettualità e all’utilizzo del simbolismo.
Nel Comune calabrese di Papasidero (Cosenza), all’interno del Parco del Pollino, si trova la Grotta del Romito che conserva una delle più antiche e importanti testimonianze di arte rupestre a livello europeo. Romito è anche il nome di due dei nove uomini ritrovati nella grotta, due disabili che hanno gettato nuova luce sul significato che la malattia e la disabilità assumevano nel contesto culturale delle prime società organizzate.
Uno di questi nostri antenati – nome completo attribuitogli dagli studiosi Romito 2 – è il primo caso riconosciuto nella storia umana di nanismo; le analisi hanno dimostrato infatti che era affetto da una patologia congenita chiamata displasia acromesomelica. Era alto poco più di un metro, la bassa statura e gli arti molto corti gli precludevano attività pesanti come la caccia. Ciò nonostante l’analisi dei suoi resti ha dimostrato che è stato curato e accudito fino all’età di vent’anni, quando è venuto a mancare. L’affetto che gli altri membri del gruppo avevano per lui sarebbe evidente anche nel tipo di insolita sepoltura che gli è stata riservata, coricato accanto ad una donna pressappoco della stessa età con la testa appoggiata sulla spalla di lei in un gesto di protezione, quando nelle tombe doppie del periodo i corpi venivano semplicemente avvicinati.

Nella medesima grotta è stato ritrovato anche Romito 8, tutt’altra corporatura rispetto al suo omonimo, forte e robusto come si richiedeva per sopravvivere 12.000 anni fa. Viveva accovacciato, come ci dice la forma delle gambe, inoltre aveva le vertebre schiacciate e una paralisi delle braccia, oltre ad altre lesioni ossee che fanno pensare ad una caduta dall’alto che gli procurò una grave disabilità. I denti sono usurati fino alla radice, un fatto non imputabile all’alimentazione, il che fa supporre li abbia usati per svolgere qualche mansione, ad esempio rendere più morbidi alcuni materiali vegetali masticandoli, per poterli poi impiegare nella costruzione di ceste o stuoie.
Se la supposizione fosse esatta, saremmo di fronte al primo caso noto di un uomo non autosufficiente integrato nella società, che lavora per contribuire al benessere di tutti. Romito 8 è stato assistito nelle necessità quotidiane che non poteva assolvere in autonomia; non siamo pertanto di fronte ad un semplice caso di “tolleranza” come era accaduto per Romito 2 che, nonostante la disabilità, poteva muoversi liberamente.
Queste deduzioni della bioarcheologia delle cure sanitarie – branca di studio che punta a formulare diagnosi cliniche e a descrivere il significato che determinate condizioni fisiche avevano nelle civiltà antiche – hanno interessato anche M9, un uomo di circa 20-30 anni ritrovato nel Nord del Vietnam in un cimitero del Neolitico (il più recente periodo dell’Età della Pietra).
Pare soffrisse della sindrome di Klippel-Feil, caratterizzata dalla segmentazione anomala e dalla fusione delle vertebre cervicali; gli arti superiori e inferiori atrofizzati sono riconducibili ad una paraplegia o tetraplegia sopravvenuta in adolescenza.
M9 è stato benvoluto: i membri del suo gruppo, che si dedicavano alla caccia e alla pesca, allevavano qualche maiale e non conoscevano i metalli, spendevano tempo ed energie per soddisfare i suoi bisogni. Questo deve avergli procurato una certa stima di sé che senza dubbio l’ha aiutato a vivere a lungo, considerando le condizioni di salute e l’epoca in cui è vissuto.
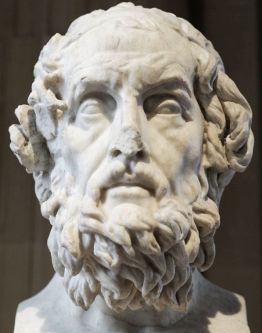
La sindrome di Klippel-Feil accomuna probabilmente l’uomo vietnamita a una celebrità della storia: il Faraone Tutankhamon. Il sovrano più enigmatico della storia e quello con la tomba più famosa e ricca di tesori, non aveva la mascella squadrata e le labbra carnose della sua maschera funeraria, neppure il fisico atletico che immaginiamo. Gli esami radiografici cui è stata sottoposta la mummia, infatti, hanno rivelato che era piuttosto “goffo”, alto e di corporatura molto esile, con denti sporgenti, fianchi larghi disallineati, una curvatura anormale della colonna vertebrale, un collo molto corto, le prime vertebre cervicali unite e un piede equino che lo obbligava ad un’andatura zoppicante. Per questo motivo, tra le centinaia di oggetti del suo corredo funerario, ritrovati nel 1922 in Egitto, nella Valle dei Re, figurano ben centotrenta bastoni da passeggio, tutti usati.
Un faraone con disabilità, dunque, sulla cui morte gli studiosi si interrogano da anni: omicidio, un incidente di caccia oppure una caduta da cavallo? La seconda e la terza supposizione potrebbero essere scartate in quanto proprio la disabilità gli avrebbe impedito di cavalcare e di reggere sforzi fisici e lasciamo l’ipotesi dell’uccisione ai “complottisti”. Una delle tesi ultimamente più gettonate, in seguito ad ulteriori esami, propenderebbe perciò per una morte naturale intorno ai 19 anni dovuta ad uno squilibrio ormonale ereditario, legato alla parentela dei genitori, che insieme alla malaria contratta in seguito lo avrebbe indebolito. Analisi sulle impronte genetiche e test del DNA ricondurrebbero inoltre la sua prematura scomparsa ad alcune patologie, quali la già citata sindrome di Klippel-Feil e la malattia ossea di Köhler che limita l’afflusso di sangue agli arti.
Queste scoperte, dunque, ci fanno sentire Tutankhamon più vicino, “uno di noi”, perché comprendiamo le difficoltà che doveva affrontare, certamente con meno disagio rispetto ai suoi contemporanei con disabilità, per via della condizione sociale privilegiata.
Non andava per altro di lusso neppure ai disabili dell’antica Grecia, se è vero che Seneca scriveva: «Soffochiamo i nati mostruosi, anche se fossero nostri figli. Se sono venuti al mondo deformi o minorati dovremo annegarli. Ma non per cattiveria. Ma perché è ragionevole separare esseri umani sani da quelli inutili».
Per Platone occorreva una selezione dei genitori per evitare il concepimento di bambini con difficoltà: «Conviene che gli uomini migliori si accoppino con le donne migliori il più spesso possibile e che, al contrario, i peggiori si uniscano con le peggiori, meno che si può; e se si vuole che il gregge sia veramente di razza occorre che i nati dai primi vengano allevati; non invece quelli degli altri».
Bellezza, integrità fisica e psichica nel mondo greco erano sinonimi di grazia divina, qualunque carattere se ne discostasse era interpretato come un castigo e chi ne era affetto doveva essere allontanato, se non addirittura ucciso. La disabilità dovuta al naturale decadimento del corpo oppure sopravvenuta per incidenti e guerre, era vista invece con compassione.

Uno dei pochi casi di persona disabile con una patologia congenita non marchiata come segno di inferiorità è Omero. Ancora si dibatte sulla sua reale esistenza, certo, leggenda o verità che sia, tutti gli indizi portano a ritenerlo un poeta errabondo non vedente, talché il nome stesso, in greco antico, significa proprio «colui che non vede».
Privo dalla nascita della vista, le Muse lo avrebbero dotato di una bella voce e della capacità di narrare le gesta degli eroi; si dice infatti recitasse a memoria quarantotto libri. «La Musa lo amò molto, ma un bene e un male gli diede: degli occhi lo fece privo e gli donò il dolce canto»: con queste parole Ulisse descrive il cantore non vedente alla corte di Alcinoo, una relazione che ci porta direttamente all’autore dell’Odissea e alla tradizione degli aedi, cantori-attori che si spostavano di corte in corte. Alcuni di loro erano non vedenti, accolti come ospiti “sacri”, in quanto si riteneva che gli dei parlassero tramite loro.
Una delle più famose scuole di aedi si trovava a Chio, l’isola dell’Egeo meridionale che si pensa abbia dato i natali a Omero: l’autore, infatti, si definisce «uomo cieco che abita nella rocciosa Chio».
Quella dei poeti non vedenti è una tradizione confermata dalla storia che risale a culture antichissime, dall’Egitto all’Antico Oriente, e si rifà al meccanismo di compensazione tra cecità e doti intellettive, oggi confermato scientificamente, per cui chi non vede è spesso dotato di memoria prodigiosa. Detto ciò, rimane il fatto che in Grecia per le persone con qualunque tipo di disabilità l’esistenza fosse difficilissima. Sappiamo che a Sparta una commissione governativa esaminava i bambini alla nascita e se presentavano malformazioni, venivano uccisi o lasciati morire per cause naturali, mentre altri piccoli venivano arruolati in guerra e il loro destino era segnato dall’impossibilità di difendersi.
Andava leggermente meglio se si aveva la fortuna di nascere nell’Atene democratica, dove albergava una “misericordia” che ricadeva anche nelle leggi. Una norma emanata da Solone prevedeva un sussidio per chi, affetto da un’invalidità, non poteva mantenersi con un lavoro, e Lisia ha scritto un’orazione per far riottenere questo sussidio ad un disabile, affermando che in un corpo non perfetto non si cela una brutta anima.
Ribalta i canoni culturali dell’epoca anche Sofocle nel Filottete (400 avanti Cristo), poema in cui trasmette al lettore la sofferenza che patisce un uomo emarginato in quanto “diverso” e si comprende come questa emarginazione fosse normale nella società greca antica.
Filottete, zoppicante a causa del morso di un serpente, viene abbandonato su un’isola dai compagni con i quali era diretto a Troia e per molti anni vive in completa solitudine, tra grandi sofferenze fisiche e psicologiche: «Quest’uomo, non secondo forse a nessuno per nobiltà di stirpe privo di ogni conforto nella vita giace qui solo, abbandonato da tutti. […] Ho pietà di lui al pensare come, senza un uomo al mondo che lo assista, senza avere accanto a sé uno sguardo amico, infelice, sempre solo, soffre per un male selvaggio». Un sentimento di empatia inusuale, questo, assai moderno per l’epoca, che va di pari passo con alcune recenti scoperte sull’accessibilità di quel periodo.
Una ricerca condotta dall’Università Statale della California ha dimostrato infatti che in un santuario dedicato ad Asclepio (Esculapio), il dio della guarigione, poco lontano da Atene, sono presenti alcune rampe tra gli scalini. Le più antiche risalgono ad oltre 2.300 anni fa e altre si trovano in alcuni edifici laterali, larghe abbastanza per poterci camminare.
È assodato che malattie simili all’artrite e patologie articolari erano piuttosto comuni, così come l’uso di stampelle dipinte anche su diversi vasi, ed è pertanto naturale che questi cittadini con difficoltà di movimento si recassero a chiedere l’intercessione della divinità per guarire e la Polis li avrebbe messi in condizione di poterlo fare con un’architettura fruibile.

Scendiamo dunque dalla macchina del tempo con un bagaglio di conoscenze che ci permette di fare riflessioni conclusive sull’attualità. Se alcune delle cose che abbiamo imparato paiono agghiaccianti, ricordiamo che non sono così lontane da noi, dal momento che determinati “approcci” sono il fondamento dello sterminio delle persone con disabilità durante il nazismo.
La deriva della discriminazione in base a requisiti di salute e integrità fisica è sempre dietro l’angolo. Nel 2006, ad esempio, il Royal College of Obstetricians and Gyneacology, l’Associazione dei ginecologi inglesi, ha chiesto la possibilità di sopprimere i neonati con disabilità, per risparmiare sofferenze e problemi economici alle famiglie; lo stesso anno in Olanda è stato emanato il cosiddetto “Protocollo di Groningen” che individua le categorie di bambini con malattie genetiche a cui dare l’eutanasia. E ancora, nel 2012 la Danimarca si è prefissata l’obiettivo di eliminare la sindrome di Down dal Paese entro il 2030, offrendo diagnosi prenatale gratuitamente e incentivando l’aborto selettivo. Soltanto nel 2012, infine, la Commissione Affari Generali del Senato Federale ha aperto un’inchiesta sulle sterilizzazioni forzate su persone con disabilità in Australia, un drammatico fenomeno a lungo taciuto.
Fa male anche solo scrivere questi fatti, ma pure noi in Italia non ne siamo esenti. Il sotterraneo fastidio verso le “vite imperfette” è nella cronaca che riporta episodi di violenza fisica e psicologica sulle persone più deboli, è nel web, dove filmati e commenti improponibili raccolgono consensi, è nelle scelte di chi ci governa, che ogniqualvolta sia necessario risparmiare sulla spesa pubblica, taglia i servizi sociali e sanitari, come se lo spreco si annidasse sempre lì. Ed è anche nel tono delle notizie date in questo periodo di coronavirus: sin da marzo, infatti, la frase che accompagna la notizia dei decessi di persone anziane o con fragilità è «era affetto/a da patologie pregresse», senza dimenticare che si è parlato di selezionare i pazienti in terapia intensiva sulla base dell’età e delle preesistenti condizioni di salute.
La società, quindi, non sembra ancora avere superato l’idea di una “selezione naturale” per cui deve andare avanti il più forte perché è migliore e più utile.
Articoli Correlati
- L'integrazione scolastica oggi "Una scuola, tante disabilità: dall'inserimento all'integrazione scolastica degli alunni con disabilità". Questo il titolo dell'approfondita analisi prodotta da Filippo Furioso - docente e giudice onorario del Tribunale dei Minorenni piemontese…
- Per un nostro dibattito scientifico «Urge la nostra fondamentale presenza in qualità di studiosi - scrive Claudio Roberti - perché dobbiamo poter dire: “Niente su di Noi senza di Noi", anche in tale ambito». E…
- La spesa sociale in Italia: 1990-2005 Uno studio approfondito sulla spesa sociale nel nostro Paese, che prende come riferimento tutti gli anni Novanta e l'inizio di questo decennio, presentando dati significativi e proponendo anche una serie…

