
Nel corso degli anni sono stati realizzati – e successivamente modificati – una serie di simboli rappresentanti la disabilità. Un esempio recente è la nuova versione del Marco Cavallo, emblema della lotta sociale per la chiusura dei manicomi e la conseguente libertà delle persone con disabilità psichica, portata a termine a Fucecchio, in Provincia di Firenze [se ne legga ampiamente anche sulle nostre pagine, N.d.R.]. Il primo Marco Cavallo fu realizzato all’interno del manicomio di Trieste nel 1973 per volontà del direttore di allora, Franco Basaglia. Suo cugino, l’artista Vittorio Basaglia, creò un cavallo di legno e cartapesta, di dimensioni monumentali, una sorta di “Cavallo di Troia” che potesse essere il simbolo della fine dell’isolamento, e la richiesta di libertà e umanità dei malati mentali.
A distanza di quasi cinquant’anni, la Cooperativa Sinergica degli Ortolani Coraggiosi e il Coordinamento Toscano delle Associazioni per l’Autismo hanno voluto dare un volto nuovo al Marco Cavallo per ribadire la necessità dell’inclusione delle persone autistiche, venuta meno in questo periodo di pandemia. Sono stati proprio ragazzi autistici e/o con una disabilità intellettiva, coordinati dall’artista Antonio Massarutto, a portare a termine l’opera costruita in legno e viti.

Il nuovo Marco Cavallo, con la sua forza simbolica, ha “galoppato” per le vie della città, portando messaggi di libertà e di vita e, allo stesso tempo, sono state consegnate le aspirazioni dei ragazzi stessi, il loro desiderio di vita, di lavoro, di casa e di stare vicino ai loro cari e agli amici.
Oltre alla storia del Marco Cavallo, meritevole di attenzione è l’evoluzione del simbolo classico riguardante l’accessibilità, nato alla fine degli Anni Sessanta.
In quel decennio vi fu un vero e proprio proliferare di simboli. Per fare un po’ di ordine, nel 1968 fu indetto un concorso finalizzato alla creazione del contrassegno internazionale dell’accessibilità (ISA- International Symbol Access), che venne vinto dalla studentessa di design Susanne Koefoed, con la messa a punto di un riquadro blu, al centro del quale vi era la figura stilizzata di una persona in sedia a rotelle, indicante un accesso privo di barriere. In poco tempo tale simbolo venne conosciuto e utilizzato in tutto il mondo.

Nel 1994, poi, Brendan Murphy, studente dell’università statunitense di Cincinnati, propose una modifica al simbolo coniato dalla Koefoed, per evidenziare l’importanza dell’indipendenza delle persone con disabilità. Mantenendo cioè la figura stilizzata in carrozzina in colore bianco sullo sfondo azzurro, venne cambiata la posizione del corpo, busto chinato in avanti e braccia indietro che spingono la carrozzina in movimento. Un’immagine, questa, che intendeva simboleggiare la conversione dei vecchi paradigmi, come staticità e passività, tipici del precedente logo, con nuove valenze, come dinamicità e partecipazione attiva.
Nel nuovo millennio, e precisamente nel 2013, Brian Glenney, professore di filosofia al Gordon College nel Massachusetts, in collaborazione con la designer Sara Hender crearono The Accessible Icon Project, simbolo internazionale dell’accessibilità, un nuovo logo molto simile al precedente con alcuni dettagli ben evidenziati, come la testa inclinata in avanti, il braccio piegato all’indietro e i tagli sulla ruota.
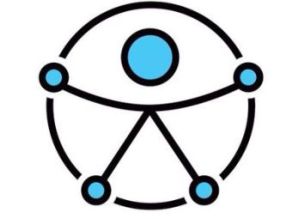
Due anni più tardi, nel 2015, sono state le Nazioni Unite a coniare l’Accessibility Logo [se ne legga anche in «Superando.it», N.d.R.], una figura stilizzata con gambe e braccia aperte racchiusa in un cerchio che ne esprime la portata globale.
La raffigurazione stessa ricorda l’Uomo Vitruviano di Leonardo Da Vinci e l’obiettivo è quello di superare la visione della persona limitata alla sedia a rotelle, valorizzando allo stesso tempo l’unicità dell’essere umano. Quest’ultimo simbolo, tuttavia, ha avuto poco successo, poiché non è riuscita a sfatare l’immagine classica della persona in carrozzina.
Il presente contributo è già apparso in “InVisibili”, blog del «Corriere della Sera.it» (con il titolo “Disabilità, l’evoluzione dei simboli (ma la carrozzina resiste)”). Viene qui ripreso – con minimi riadattamenti al diverso contenitore – per gentile concessione.
Articoli Correlati
- L’arte elogia la follia: la malattia mentale nelle opere dei grandi artisti Spazia dal Medioevo ai giorni nostri il ricco approfondimento dedicato al rapporto tra arte e follia, curato da Stefania Delendati, che scrive tra l’altro: «In un certo senso l’arte, se…
- Internate in manicomio perché “non conformi” Un viaggio di dolore ed emarginazione lungo quasi un secolo, dentro ai manicomi italiani, dove centinaia di donne furono rinchiuse, spesso senza tornare mai più ad una vita normale. Un…
- Storia di Marco Cavallo, che continua a lottare contro ogni discriminazione «C’era una volta un cavallino di nome Marco che trainava il carretto della lavanderia…»: comincia come una favola la storia di Marco Cavallo, la scultura realizzata nel 1973 dai degenti…

