«Il nostro invito – scrive Laura Giordani, audiodescrittrice e adattatrice di dialoghi -, che è poi il desiderio di tante persone che prendono parte alla produzione, post-produzione e fruizione di opere audiovisive, è che il pubblico vedente ancora ignaro delle meraviglie di questo formidabile strumento che è l’audiodescrizione, si avvicini con fiducia ad esso, per conoscerne le potenzialità e, perché no, i cultori appassionati»
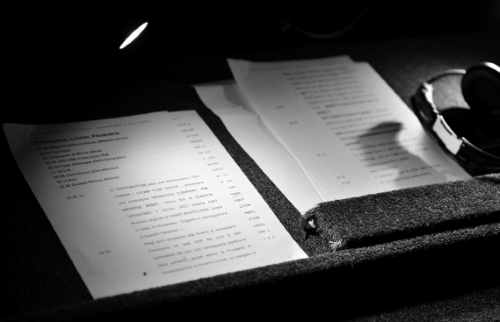
Quando si parla di audiodescrizione, quel che ad alcuni viene in mente è un piccolo team di professionisti che, immerso nel buio di una sala di incisione, si dedica a ore di interminabile lavoro perseguendo l’obiettivo – a prima “vista” impossibile – di rendere un film accessibile a persone cieche e ipovedenti.
Un altro luogo comune, ugualmente diffuso, risiede nello scetticismo di chi, sentendosi raccontare gli sforzi che si fanno per garantire l’accessibilità, reagisce con un «Ma i ciechi guardano i film?».
Io non credo che idee vaghe e pregiudizi come questi siano da condannare a priori, senza cioè possibilità d’appello. Non credo che il fatto di non conoscere determinate realtà sociali basti a bollare qualcuno in maniera negativa. Il mondo è vasto, un insieme di fenomeni complessi in costante mutazione. Non avere mai riflettuto sull’impatto che l’accessibilità delle opere filmiche, uniche o seriali che siano, ha sulla vita della gente e sull’impegno che molti descrittori mettono oggi nel garantire che tale diritto sia riconosciuto e di conseguenza fruito nel migliore dei modi possibili, non rappresenta in sé una colpa. A patto, però, che si sia disposti ad ascoltare, con mente aperta.
L’audiodescrizione (d’ora in poi semplicemente AD) è ormai una realtà consolidata da più di mezzo secolo. La sua genesi accademica risale ai pionieristici studi condotti da Gregory Frazier, professore di Scienza della Comunicazione alla State University di San Francisco. Nel campo applicato (oltre che nella ricerca) è bene poi ricordare il prezioso contributo di Joel Snyder, a oggi uno dei massimi esponenti internazionali nell’ambito dell’audiodescrizione.
A partire dagli Anni Settanta, la riflessione su modalità creative, regole formali e applicazioni di questo strumento di eguaglianza sociale ha portato a conquiste che segnano a fondo l’evoluzione della storia del diritto alla cultura. Eppure, nell’immaginario collettivo, la figura dell’audiodescrittore corrisponde ancora a un qualcosa di molto nebuloso, o, nel migliore dei casi, di poco compreso.
Questo genere di professionista è un esperto descrittore di film, serie televisive, cartoni animati, eventi sportivi, spettacoli teatrali e di opere esposte in musei e gallerie. Le sue doti sono al servizio – un concetto chiave per chiunque cerchi di delineare la missione dell’audiodescrittore – di fruitori ciechi e ipovedenti desiderosi di attingere da un patrimonio audiovisivo pressoché sconfinato.
Va anche ricordato, e ribadirlo è sempre un bene, che l’audiodescrittore non rappresenta una monade isolata, avvolta dal buio del proprio studiolo, ricurva su copioni di opere che da immagini si trasformeranno in parole. Si tratta invece di un singolo tassello facente parte di un insieme più grande, che contribuisce a fornire un servizio frutto di un impegno collettivo – un impegno sinergico.
Sinergico dev’essere, infatti, il rapporto tra descrittore e committenza. Uno scambio professionale basato dunque sulla reciproca fiducia che culmina, prima della messa in onda o pubblicazione, nel collaudo delle AD – auspicabilmente anche con la consulenza di persone cieche e ipovedenti – e si rinsalda calendarizzando tempi di lavorazione proporzionati alla complessità e all’estensione delle opere da descrivere.
Sinergico dev’essere il lavoro del descrittore, quando collabora con una squadra di colleghi alla creazione autoriale di AD per opere seriali o franchise cinetelevisivi. In questi casi, il confronto tra prospettive e stili differenti costituisce una risorsa di valore, da cui il testo descrittivo non può che uscire arricchito, anche in virtù della cooperazione – ancora una volta necessaria e auspicata – di professionisti ciechi e ipovedenti.
Sinergico è poi l’interscambio tra le figure della cosiddetta “filiera dell’AD”, la catena di montaggio grazie a cui il testo descrittivo viene registrato e missato a un’opera audiovisiva, rendendola, a tutti gli effetti, accessibile al pubblico cieco e ipovedente. Le figure coinvolte nel processo sono molte e molto specializzate. A partire dall’autore della descrizione, passando per lo speaker, la cui voce verrà ascoltata dai fruitori a lavorazione terminata e collaudata, fino ai fonici di sala, di mix e sincronizzatori, ai quali sono affidati incisione, sincronizzazione e missaggio della traccia audio.
Sinergico, infine (ed è qui che sentiamo di offrire a Lettori e Lettrici un piccolo spunto di riflessione) dev’essere il rapporto che lega l’arte ausiliaria dell’audiodescrizione a tutti i membri della società civile, accanto e in mezzo ai quali persone cieche e ipovedenti vivono e coesistono quotidianamente. Approfondire la conoscenza di questo potente strumento di inclusione e familiarizzare con il lavoro di chi fornisce (e di chi richiede) accessibilità, non è semplicemente l’ennesimo “dovere morale” da “buoni samaritani”. Al contrario, costituisce un’opportunità. È una finestra aperta su un mondo che stupirà chi ancora non ne ha fatto esperienza, ed è una porta (anzi, un portone) che ci consente di condividere con figli, fratelli, familiari e amici con disabilità visiva abitudini che a noi paiono basilari, ma che sono tutt’altro che scontate. Si pensi, per esempio, a passatempi di per sé ordinari come guardare una soap o un programma sul divano, andare al cinema dopo la “pizzata” del venerdì sera, assistere a un evento sportivo in uno stadio, o godere di uno spettacolo teatrale in compagnia dei nostri cari. Tutte queste attività fanno da collante sociale e veicolo di cultura senza che noi, “cittadini vedenti” abituati, ce ne rendiamo neanche conto.

Includere, piuttosto che bypassare, è qualcosa che non si può rimandare, nel nostro Paese: profonde innovazioni teoriche e tecnologiche supportano oggi, a tutti gli effetti, questo irrinunciabile salto in avanti, alla luce anche dei recenti sviluppi legislativi che consentiranno, nel prossimo futuro, il fiorire di un àmbito e di un mercato già in espansione a livello sia nazionale che internazionale.
L’auspicio, ancora una volta, è che anche l’Italia partecipi a questo andamento globale, rivedendo tutte quelle leggi che escludono le disabilità dalla cultura e dall’intrattenimento, e attuando la Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, che garantisce pari opportunità a tutti gli esseri umani e che all’articolo 30 (Partecipazione alla vita culturale e ricreativa, agli svaghi ed allo sport) recita tra l’altro: «Gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità a prendere parte su base di uguaglianza con gli altri alla vita culturale e adottano tutte le misure adeguate a garantire che le persone con disabilità: (a) abbiano accesso ai prodotti culturali in formati accessibili; (b) abbiano accesso a programmi televisivi, film, spettacoli teatrali e altre attività culturali, in formati accessibili; (c) abbiano accesso a luoghi di attività culturali, come teatri, musei, cinema, biblioteche e servizi turistici, e, per quanto possibile, abbiano accesso a monumenti e siti importanti per la cultura nazionale».
Accanto poi a queste importantissime direttive, ci sono i princìpi espressi nell’articolo 3 della Costituzione Italiana, secondo cui: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese».
A coronamento infine di uno status quo ancora in via di definizione, la Legge Cinema n. 220 del 2016 stabilisce che chiunque si rivolga al Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, per ricevere il sostegno relativo al Tax Credit, debba depositare presso la Cineteca Nazionale audiodescrizioni e sottotitoli per non udenti. Tuttavia, in questo caso, non viene fatto alcun riferimento alla fruizione: la condizione sufficiente è la mera consegna. Viene quindi spontaneo chiedersi il perché di una scelta simile. Perché obbligare le produzioni a investire soldi in ausili che vengono poi chiusi nelle “cassette di sicurezza” della Cineteca Nazionale?
Un cenno finale, tanto doveroso quanto interessante per il cosiddetto “pubblico dei non addetti ai lavori” va all’utilizzo che sempre più spesso si fa dell’AD come strumento di apprendimento linguistico. Ne sono testimoni tutti quegli studenti di italiano per stranieri che si avvalgono dei metodi di insegnamento integrato – che comprendono quindi il ricorso a opere audiovisive audiodescritte – di tanti docenti desiderosi di tenersi al passo coi tempi anche mediante opere di produzione cine-televisiva.
In conclusione, il nostro invito, che è poi il desiderio di tante e tante persone che prendono parte alla produzione, post-produzione e fruizione di opere audiovisive, è che il pubblico vedente ancora ignaro delle meraviglie di questo formidabile strumento descrittivo si avvicini con fiducia al mondo delle AD, per conoscerne le potenzialità e, perché no, i cultori appassionati. Farlo non costa poi molto, basta premere i pulsanti di un telecomando e selezionare l’audiodescrizione di un film da una tendina su uno schermo. Che sia in italiano sulle nostre reti nazionali, o in altre lingue dalle piattaforme streaming, concedetevi la possibilità di conoscere l’universo delle audiodescrizioni nelle sue varie applicazioni. Verrete accolti a braccia aperte, e siamo certi che ne “vedrete delle belle”!
*Adattatrice dialoghi, audiodescrittrice, docente universitaria, attualmente al lavora al suo quinto libro. Il presente contributo è già apparso nella testata «Cultura e dintorni» e viene qui ripreso, con alcuni riadattamenti al diverso contenitore, per gentile concessione.
Articoli Correlati
- A tu per tu con la propria docente di audiodescrizione: Laura Giordani Con i bravi docenti e i bravi audiodescrittori, Laura Giordani condivide una dote: rendere visibile ciò che già c’era di importante, ma che non vedevamo. «Lo ha fatto anche con…
- L'integrazione scolastica oggi "Una scuola, tante disabilità: dall'inserimento all'integrazione scolastica degli alunni con disabilità". Questo il titolo dell'approfondita analisi prodotta da Filippo Furioso - docente e giudice onorario del Tribunale dei Minorenni piemontese…
- Sordocecità, la rivoluzione inclusiva delle donne Julia Brace, Laura Bridgman, Helen Keller, Sabina Santilli. E poi Anne Sullivan. Le prime quattro erano donne sordocieche, la quinta era “soltanto” quasi completamente cieca, ma non si può parlare…

