«Le leggi italiane – scrive Daniela Mariani Cerati – sono aperte e solidali, ma devono essere accompagnate da buone prassi, che a loro volta vanno pubblicizzate in modo da diventare la norma e non una lodevole eccezione. Un’esperienza esemplare riguarda la pratica di due arti marziali (judo e karate) nella scuola primaria in orario curricolare. un a ricerca che ha coinvolto 31 bambini con diagnosi di disturbo dello spettro autistico di ogni livello»
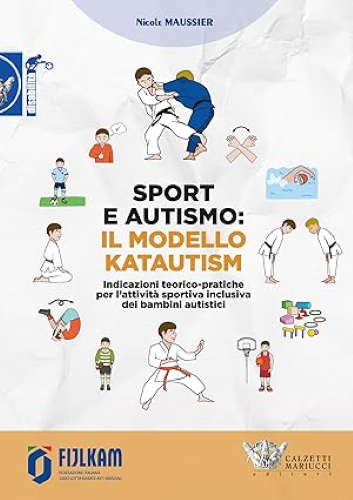
La Legge 118 del 1971, ove all’articolo 28 si stabiliva che l’istruzione dell’obbligo dovesse avvenire nelle scuole normali della scuola pubblica per tutti, con l’abolizione delle scuole speciali, fu salutata da molti come una rivoluzione, come la fine di un’ingiusta ghettizzazione delle persone con disabilità. La parola d’ordine era “integrazione”, sostituita anni dopo con la parola “inclusione”.
La partecipazione di tutti alla scuola di tutti ha portato un beneficio immediato a molte persone con disabilità, ma non a tutte. Per i casi più complessi si è visto nel tempo che l’inclusione da sola non bastava. Era necessaria una preparazione specifica e, talvolta, un insegnamento personalizzato per l’alunno con disabilità, anche al di fuori della classe.
Oscillando da un estremo all’altro, si è arrivati, in alcuni casi, a una sorta di scuola speciale con rapporto uno a uno, trascurando uno degli ideali che aveva portato alla scelta del 1971: i benefìci dell’inclusione sia per gli allievi con disabilità che per quelli “normodotati”, che dovevano sviluppare solidarietà e capacità di aiuto grazie anche agli ambienti comuni e non separati.
Non si era tenuto conto della peculiarità di alcune condizioni che rendeva difficile, per i casi più complessi, la continua permanenza in classe e la partecipazione alle attività curricolari.
Il noto neurolinguista belga specializzato in disturbi dello spettro autistico Theo Peeters aveva pronunciato un giudizio molto severo sulla scelta italiana dell’inclusione a tutti i costi, dicendo che l’integrazione prospettata dalle leggi italiane equivaleva a far correre ad una velocità da atleti persone non allenate. Un’altra criticità evidenziata dallo stesso Peeters – ma non solo da lui – era la scarsa importanza che veniva data nella scuola italiana alla formazione specifica degli insegnanti, quasi che bastasse inserire un allievo con disabilità tra quelli senza disabilità per ottenere il miracolo. La formula che lui proponeva era “integrazione inversa”, ossia che in ogni classe dove fosse presente un alunno con disabilità si cercassero delle attività adatte a lui e che queste attività, una volta individuate, venissero fatte da tutta la classe, secondo il principio per cui un campione si può adattare ad andare a passo lento, mentre una persona non allenata non può correre alla pari di un campione.
Credo che in molte scuole ci siano esperienze virtuose di insegnanti preparati e di “integrazioni inverse” che vengono praticate, ma non pubblicizzate.
Un’esperienza esemplare, che è stata pubblicata in italiano nel libro di Nicole Maussier Sport e autismo: il modello Katautism e in seguito in inglese in un’importante rivista internazionale (Maussier N., Pierantozzi E., Manno, R. et al., Judo and karate in primary school as a means for the improvement of social inclusion for autistic children, in «Sport Sciences for Health», 2025), riguarda la pratica di due arti marziali (judo e karate) nella scuola primaria in orario curricolare.
La ricerca ha riguardato 31 bambini con diagnosi di disturbo dello spettro autistico di ogni livello, inseriti in classi nelle quali c’era un solo bambino certificato, in scuole situate in ogni parte d’Italia (Nord, Centro, Sud). Le lezioni si sono svolte per due volte alla settimana e per due anni. Sono state inclusive sin dall’inizio, cioè partecipate da tutta la classe, e mai in un rapporto esclusivo tra bambino certificato e operatore. Tutti i bambini con disabilità vi hanno partecipato dall’inizio alla fine e per nessuno di loro c’è stata la necessità di un ritiro dall’esperienza.
Quali sono stati, dunque, gli ingredienti di questo successo? Una formazione specifica degli allenatori, prima generale, poi personalizzata sulle caratteristiche peculiari dell’allievo, e una semplificazione delle regole della disciplina che tenesse conto delle peculiarità dell’alunno.
Qui vedo l’attuazione del consiglio di Theo Peeters. Se cambiamo un po’ le regole semplificandole, sarà un grosso vantaggio per il bambino con disabilità e non porterà nessuna difficoltà ai bambini “normodotati”, anzi probabilmente aiuterà quei bambini che, pur non essendo certificati, non sono particolarmente brillanti.
La formazione degli allenatori ha coinvolto poi tutto il personale scolastico. Conoscendo quanto sia importante per le persone autistiche la prevedibilità degli eventi, un’agenda con il programma settimanale degli allenamenti è stata esposta in classe nel linguaggio comprensibile ai bambini interessati, che per alcuni di loro era quello della CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa).
Nella ricerca erano presenti anche gli psicologi, ma solo come osservatori ed eventualmente come consiglieri degli allenatori, ma le figure di riferimento erano gli allenatori adeguatamente formati.
Già la partecipazione in modo continuativo ad un’attività sportiva insieme ai compagni in orario curricolare sarebbe un successo e un esempio da imitare, non solo per il benessere degli allievi certificati, ma anche per i compagni normodotati, che hanno contribuito al successo dando rinforzi spontanei: lodi date all’alunno con disabilità quando questo eseguiva correttamente le azioni previste nella disciplina. Infatti, «bravo!», detto da un compagno, è un rinforzo maggiore che detto da un adulto.
Gli autori della ricerca, inoltre, non si sono limitati a documentare il successo nella partecipazione ad attività sportive da parte di alunni con disturbi dello spettro autistico, cosa già positiva in quanto favorevole per la salute generale e per la socializzazione. Hanno utilizzato infatti dei test validati in letteratura per misurare il miglioramento in tre aree critiche: livello di autismo, compromissione sociale e abilità grosso motorie. Questi test, somministrati prima e dopo i due anni della sperimentazione, hanno documentato miglioramenti statisticamente significativi in tutte e tre le aree indicate.
Si tratta di una ricerca molto importante perché dà un esempio di vera inclusione nella scuola e perché indica una strada per contrastare la sedentarietà e l’isolamento che caratterizza molte persone con disturbi dello spettro autistico. Una volta superata la fase di sperimentazione, esperienze simili dovrebbero essere generalizzate dentro e fuori dalla scuola.
Gli autori sottolineano per altro l’importanza cruciale della formazione degli allenatori, ricordando che molte persone con autismo sono escluse dalle attività sportive per la mancanza di formazione specifica degli allenatori.
Ritengo molto importante che vi sia stata una pubblicazione in inglese in una rivista internazionale, in quanto il valore dell’inclusione, che per noi italiani è fondamentale, non è condiviso da altre nazioni anche vicine. Un’insegnante italiana che insegna in Inghilterra riferisce ad esempio che là si dà importanza prevalente alla protezione dei “bambini deboli”, più che all’inclusione, mentre un’altra insegnante italiana che opera in Olanda dice che là ci sono scuole differenziate non soltanto per le diverse categorie di persone con disabilità, ma anche per i “normodotati” in base al quoziente intellettivo. Non soltanto, ma che le scuole possono rifiutare i bambini, se li ritengono troppo problematici, tanto che alcuni bambini restano in famiglia a carico dei genitori e, non essendoci opportunità di incontro tra persone con e senza disabilità, i cittadini non conoscono neppure l’esistenza e le problematiche della disabilità.
Le leggi italiane, dunque, sono aperte e solidali, ma devono essere accompagnate da buone prassi, che a loro volta vanno pubblicizzate in modo da diventare la norma e non una lodevole eccezione.
*Componente dell’APRI (Associazione Cimadori per la ricerca italiana sulla sindrome di Down, l’autismo e il danno cerebrale) e della lista di discussione Autismo-Scuola (autismo-scuola@autismo33.it).
Articoli Correlati
- L'integrazione scolastica oggi "Una scuola, tante disabilità: dall'inserimento all'integrazione scolastica degli alunni con disabilità". Questo il titolo dell'approfondita analisi prodotta da Filippo Furioso - docente e giudice onorario del Tribunale dei Minorenni piemontese…
- Il Disegno di Legge Zan e la disabilità: opinioni a confronto Riceviamo un testo dal sito «Progetto Autismo», a firma di Monica Boccardi e Paolo Cilia, che si riferisce, con toni critici, a un contributo da noi pubblicato, contenente due opinioni…
- Se la disperazione diventa un mercato: terapie ingannevoli e autismo Continuano ad emergere casi di genitori che, sopraffatti dalla disperazione, cadono vittime di percorsi alternativi e truffe in cerca di cure e soluzioni per l’autismo. Ringraziamo dunque con particolare calore…

